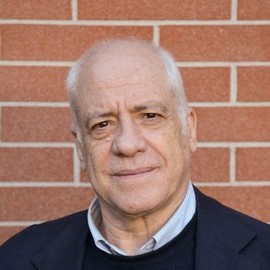L’11 maggio è morto, a 93 anni, il teologo e monaco benedettino Ghislain Lafont. Il suo nome non è forse così noto negli ambienti che non si occupano di teologia, non è stato un teologo «mediatico», né è diventato noto per posizioni polemiche o per punizioni ricevute.
Di se stesso diceva, con l’ironia che lo caratterizzava, che evidentemente la sua teologia era davvero poco rilevante, non avendo mai ricevuto una condanna dalla Congregazione per la dottrina della fede. Eppure, alla sua morte mi sono venuti immediatamente in mente i monaci benedettini che lo hanno preceduto, di cui non conosciamo neppure il nome, ma che hanno cambiato il volto dell’Europa nel tempo di transizione del VI-VII secolo, imbrigliando acque, bonificando terreni e copiando manoscritti. E mi è tornato spontaneo ricordare quanto scrive Jean Leclercq:
«Tutti i monaci hanno letto. Alcuni di loro hanno scritto. Fra questi, parecchi hanno esposto una dottrina che gli altri hanno raccolto. Cerchiamo ora di caratterizzare questa dottrina. Non che tutti gli scritti dei monaci siano stati, come quelli degli scolastici, di carattere teologico; non che tutti i monaci, o quelli tra essi che scrivevano, o tutti quelli che leggevano i loro testi, siano stati dei teologi. Ma tutti insieme costituirono un ambiente che rese possibile e necessaria la formazione di una teologia in alcuni di loro; vi furono tra essi dei teologi, e nelle loro opere una teologia indirizzata ai monaci, perché per essi fu concepita e scritta. Essa rispondeva ai loro bisogni, si adattava alle loro esigenze: per questi motivi è stata chiamata “teologia monastica” […] Ora gli autori dell’età patristica o del Medioevo non hanno fatto della teologia allo scopo di preparare una teologia futura: essi ne hanno fatta perché la vita della Chiesa ne esigeva, come lo esigeva la loro vita, nel tempo in cui vivevano, e si sono dati la teologia che dovevano e potevano darsi» (Cultura umanistica e desiderio di Dio, Sansoni, 1965).
Lafont è stato un monaco e un teologo di un tempo di transizione, il nostro, che ha avuto il coraggio di non ritrarsi mai di fronte a essa: muovendosi da una formazione teologica classica (la sua tesi dottorale era sulla struttura e il metodo della Summa theologiae, ed è stata pubblicata nel 1961, prima del Concilio Vaticano II), ha saputo accogliere le crisi dei tempi lasciandosene trasformare e spostare fino ai suoi ultimi piccoli volumi (Piccolo saggio sul tempo di papa Francesco, Dehoniane, 2017 e Un cattolicesimo diverso, Dehoniane, 2019), seguendo sempre il principio che così ha enunciato in un altro dei suoi testi: «L’uomo non ha potere sul racconto della sua nascita; ma gli compete in seguito fare del suo nome ciò che vuole: aprirsi agli appelli che questo nome riceve o chiudersi su un nome divenuto sterile» (Dio, il tempo e l’essere, Piemme, 1992).
Egli davvero si è dato, e ci ha dato, la teologia che doveva e poteva darsi e darci, rispondendo agli appelli che il suo nome ha ricevuto, appelli in forma di chiamata del cardinale Martini, allora vescovo di Milano, come di piccoli gruppi di semplici credenti della periferia romana (per dire solo dell’Italia, senza contare l’Africa e gli altri luoghi). E anche gli appelli, più nascosti e spesso più dolorosi, che il suo pensare inquieto poneva al suo stesso nome, che gli occhi aperti sulla realtà ponevano, occhi che hanno visto, dal silenzio di un monastero nel folto del Morvan, come dalle aule delle università romane, ciò che nel mondo accadeva e accade.
Egli davvero si è dato e ci ha dato la teologia che doveva e poteva darsi e darci, rispondendo agli appelli che il suo nome ha ricevuto, anche i più nascosti e spesso più dolorosi che il suo pensare inquieto gli ponevaIl suo itinerario ha segnato molti: i lettori dei suoi libri che lo hanno seguito nell’Immaginare la Chiesa cattolica (San Paolo, 1998), gli ascoltatori delle sue conferenze, ma soprattutto gli studenti a cui ha offerto un ambiente che ha reso possibile e necessaria la formazione di una teologia in alcuni di loro; studenti che oggi sono a loro volta professori o vescovi, in Italia e nel mondo, a cui ha donato la ricchezza, la profondità e il rigore necessari a non aver paura di farsi le domande che sono vere, quelle di cui davvero non si conosce la risposta e che fanno tremare i polsi e i pensieri, domande per una teologia che non riguardi solo i teologi, ma gli uomini e le donne, i Paesi, le città, le comunità dei viventi: Che cosa possiamo sperare? (Dehoniane, 2011) si chiede ad esempio il titolo di un ulteriore suo volume. Domanda semplice, basilare, seria come tutte le domande davvero importanti e che, credo, in questo tempo di pandemia hanno attraversato tutti, senza eccezione.
Per tutta la sua vita di studi e di ricerca, Lafont è rimasto un «teologo classico», con il rigore di una formazione di sapore e valore antichi, ma è sempre stato curioso, un ottimo ascoltatore e un intelligente bracconiere (ammirato e grato) dei saperi altrui, amante del cinema che ha usato nelle sue lezioni condividendo una sapienza degli occhi e delle emozioni che non si fa rendere sterile dalla prigione del metodo intellettuale, ma piuttosto usa insieme larghezza e precisione, con la passione dell’intelligenza e le ragioni del cuore. Una sapienza monastica, che non è solo puro sapere, ma anche la capacità di avere sapore.
In tutta la sua vita è rimasto un teologo classico, con il rigore di una formazione di sapore e valore antichi, ma sempre bracconiere dei saperi altrui, condividendo una sapienza degli occhi e delle emozioni che non si fa rendere sterile dalla prigione del metodo intellettualePer tutti i suoi giorni ha cercato di mettere parole sul mistero di Dio e della Chiesa, parole per la vita degli uomini e delle donne, non ha mai smesso di parlare e scrivere… Tanto abbiamo riso sui molteplici annunci che si ripetevano circa il fatto che quello appena uscito sarebbe stato il suo ultimo libro, cui seguiva un altro ultimo libro e così via. Eppure, tra le sue ultimissime (queste sì ultime) annotazioni si legge «Au fond, je ne sais pas»: intellettuale vulnerabile, consapevole, parziale, ci ha donato la gioia liberante di poter non sapere in questo cambiamento d’epoca, senza per questo smettere di cercare le parole per dirlo, parole che ci accompagnino e ci accomunino per tessere una trama di cura vicendevole e di possibilità di futuro.
Secondo la tradizione cabalistica ebraica, in ogni generazione ci sono trentasei giusti nascosti che accolgono lo splendore di Dio e reggono il mondo; in mancanza di anche uno solo di essi il mondo crollerebbe, quindi speriamo che da qualche parte nel mondo qualcuno abbia raccolto il testimone di Ghislain Lafont, perché il mondo possa ancora essere e sperare.

Riproduzione riservata