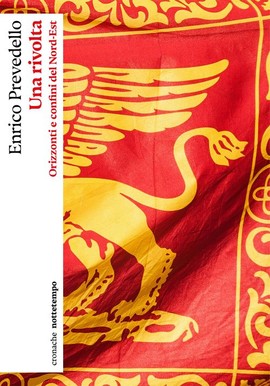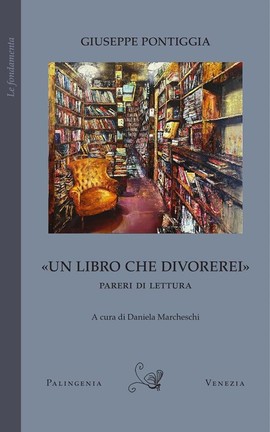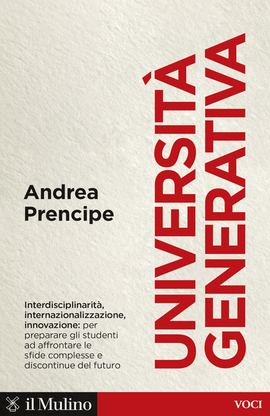Essere morali dipende «dalla particella "no", presente in tutte le lingue». Così insegna Zygmunt Bauman, e le sue parole tornano alla mente leggendo le ottanta dense pagine della nuova edizione di Elogio della disobbedienza civile (Nottetempo, 2022).
La disobbedienza può anche essere incivile, avverte Goffredo Fofi nel primo capitoletto del suo libro, riprendendo un giudizio di Carlo Donolo. Incivili, precisa, sono le disobbedienze delle minoranze arroganti e ricattatorie che si volgono contro la maggioranza, per esempio non pagando le tasse. D’altra parte, così ci viene da commentare, può bene accadere che queste stesse minoranze considerino civilissime le proprie disobbedienze, e che lo facciano sulla base di un egoismo che non avvertono come tale, giudicandolo invece moralmente fondato, se non addirittura «naturale». Così accade nella prospettiva culturale – nel senso di ideologica – che si è andata affermando nei decenni e che, in quanto ideologia, pare condivisa dalla maggioranza dei «ricattati».
Quale criterio distingue le due diverse, e opposte, disobbedienze? Civile, scrive Fofi citando la filosofa politica Teresa Serra, è «una violazione intenzionale, disinteressata, pubblica e pubblicizzata di una legge valida, emanata da un’autorità legittima». Quanto all’evasione fiscale, per restare al nostro esempio, si tratta certo della violazione intenzionale di una legge valida emanata da un’autorità legittima, ma – a prima vista – non disinteressata, non pubblica e non pubblicizzata. E però, se ci si mettesse nella prospettiva ideologica ricordata, sviluppandola fino al paradosso, si potrebbe sostenere che non pagare le tasse significhi da un lato difendersi dall’invadenza dello Stato e dall’altro, se si è ricchi, contribuire al benessere di tutti, sulla base della (involontariamente comica) teoria detta in inglese del trickle-down, e in italiano dello sgocciolamento verso il basso della ricchezza accumulata da pochi.
L’evasione fiscale – potrebbero sostenere le minoranze arroganti e ricattatorie – è un «egoismo non egoista», che finisce per fare l’interesse dei poveri e disagiati. Che la loro disobbedienza non sia pubblica e pubblicizzata è poi da dimostrare, data l’impudenza con cui è praticata, e con cui una parte della politica la blandisce e favorisce a scopo di consenso.
Lasciamo ora questo paradosso più o meno fondato, non dimenticando però che a renderlo un po’ meno paradossale – e a farlo diventare opinione dominante, spesso anche nelle teste dei poveri e disagiati – è il disastro del pensiero diffuso, che Fofi non manca di sottolineare. Nell’ultimo trentennio, scrive, la cultura «è diventata la merce fondamentale della distrazione di massa». E chi ne vive – gli intellettuali – accetta la propria sudditanza alla sua banalità e superficialità nella speranza di una notorietà mediatica in un mare di «chiacchiere da salotto». «Il giornalismo in genere (quotidiani e settimanali, mensili e riviste specializzate), assumendo gli stessi modelli della comunicazione televisiva, ha proposto al più nuovi divi e divetti della "cultura", imbonitori […] la cui funzione è sempre di tranquillizzare e mai di inquietare».
Inquietare, o almeno disturbare, questo dovrebbe essere il compito degli intellettuali, e questo dovrebbe essere il compito dei disobbedienti, siano intellettuali o non lo siano
Inquietare, o almeno disturbare, questo dovrebbe essere il compito degli intellettuali, e questo dovrebbe essere il compito dei disobbedienti, siano intellettuali o non lo siano (Fofi si rivolge soprattutto ai secondi, quasi temendo l’inclinazione alla «sudditanza» dei primi). Nelle pagine di Elogio della disobbedienza civile, alla definizione della disobbedienza data da Serra si aggiunge di fatto questa condizione di possibilità: la violazione intenzionale, disinteressata, pubblica e pubblicizzata di una legge valida, emanata da un’autorità legittima, deve essere contro la pigrizia del pensiero dominante, contro gli interessi e gli egoismi delle minoranze che lo producono e lo controllano, stiano nelle redazioni di qualche giornale, negli studi di qualche emittente televisiva o su qualche cattedra universitaria. La disobbedienza è civile se mette in dubbio, se contrasta, se cerca e crea parole e «luoghi» in cui non possa mettere radici il potere, né quello che si nutre di arroganza e ricatto, né quello di un cultura-merce che di tutto fa banalità e superficie.
Per quanto ben viva, la prospettiva politica e morale di Fofi è segnata da un’ombra di disillusione. Non essendo riusciti a essere sempre e davvero contro, e condividendo almeno in parte il disastro del pensiero diffuso, i disobbedienti corrono il rischio di immiserire il loro impegno, di farne una questione «di fine settimana», di ridurlo a «feste periodiche di massa». Così scrive, rinnovando l’amarezza di un grande pacifista (e filosofo, oltre che intellettuale) come Günther Anders: «Non appena si mettono insieme in centomila, automaticamente ne scaturisce una divertente festa popolare. Allora ci sono salsicce, […]. E poi vengono le chitarre. E là dove quelle cominciano, là comincia la scemenza emotiva».
C’è poi, nelle pagine intense di Elogio della disobbedienza, una questione ulteriore, più radicale, quella del rapporto fra disobbedienza e nonviolenza. La seconda non può fare a meno della prima: non si è nonviolenti senza essere anche disobbedienti. Ma può la disobbedienza fare a meno per principio della violenza? Un passaggio, nel ragionamento di Fofi, mostra quanto la domanda sia tragica, nel senso che è arduo scioglierne la complessità.
C’è poi, nelle pagine intense di Elogio della disobbedienza, una questione ulteriore, più radicale, quella del rapporto fra disobbedienza e nonviolenza. La seconda non può fare a meno della prima: non si è nonviolenti senza essere anche disobbedienti
«Un’ingiustizia subita o vista subire da altri è una forma di violenza che, dice Thoreau e insiste Gandhi, non va accettata e a cui è doveroso rispondere». E però, continua Fofi, Thoreau non esclude affatto il ricorso a mezzi violenti, mentre Gandhi lo giustifica solo in casi «davvero estremi». Anche il disobbediente Anders, ricorda verso la fine del libro, non esclude la violenza. Questa sua scelta è preoccupante, commenta, e tuttavia è comprensibile.
Non solo Thoreau, Gandhi e Anders sono implicati nella domanda radicale e tragica, e nelle risposte possibili, ma anche Albert Camus, che Fofi non cita esplicitamente, ma che è ben presente nel suo pensiero e nella sua capacità di sentire il mondo, e gli altri nel mondo. Direbbe Camus che un conto è subire un’ingiustizia, e un conto vederla subire da un terzo. In questo caso, soprattutto in questo caso, il grande francese vede nascere il moto della rivolta. Io posso anche subire un’ingiustizia, se rifiuto la violenza, ma di fronte al dolore dell’altro mi sento costretto a fermare la mano del violento. E in più di un caso non la posso fermare, se escludo per principio una mia violenza in grado di mettere fine alla sua.
Pur senza riferirsi a Camus, Fofi affronta la complessità di una tale situazione assumendone di fatto la prospettiva morale. Non mi rassegno all’idea di essere anche io violento, scrive, e tuttavia «credo che, momento per momento, si tratti sempre di non assolutizzare le posizioni, ma di commisurarle alla gravità della situazione».
È inevitabile che sia oggetto di critiche, anche di rifiuti più o meno assoluti, questo «relativismo» – questo decidere non sulla base di un principio superiore, ma in relazione con l’altro e con il suo dolore. Nella complessità tragica della nostro vivere, alcuni si affidano alla certezza di leggi morali già tutte scritte, altri si assumono il peso e la responsabilità di decidere. Per tornare a Bauman, e alla particella presente in tutte le lingue, essere morali per questi ultimi significa poter dire no, non solo al potere, non solo alle ideologie, ma anche a quell’assoluto per così dire «nucleare» che alla lunga alimenta quelli e a queste, l’assoluto delle proprie certezze che si pretendono Verità, e che minacciano di chiuderci in qualche minoranza arrogante e ricattatoria. Se non si è contro se stessi – anche contro se stessi – è difficile essere disobbedienti. Ed è impossibile essere liberi.
[Sul numero 3/22 potete leggere un'intervista di Bruno Simili a Goffredo Fofi]

Riproduzione riservata