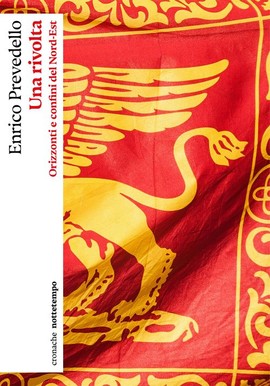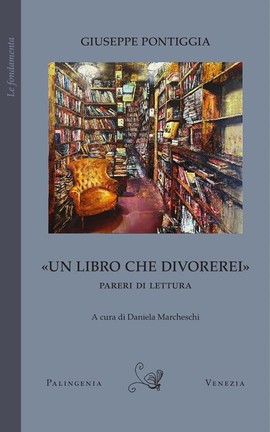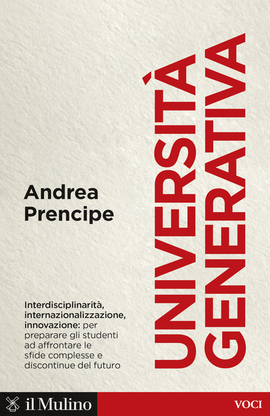Un discorso largamente inedito e molto suggestivo lega i differenti piani di lettura che possono essere individuati nel recente e-book di Madel Crasta (Di chi è il passato? L’ambiguo rapporto con l’eredità culturale, Roma, Garamond, 2013). Il primo piano (in tacita polemica con tutte le ideologie liquidatorie del passato: per dire, il troppo celebrato libro di Fukuyama del 1992, The End of History and the last man, pubblicato in italiano come La fine della storia e l'ultimo uomo) è la convinzione della forte valenza attuale del passato, e anzi della sua ineludibilità come materiale di base sul quale costruire non solo il presente ma il futuro delle società contemporanee. Non è un concetto scontato, perché viviamo nel tempo della istantaneità e dell’oblio (sotto questo profilo la stessa trasformazione delle società contemporanee, sempre più frammentarie e individualizzate, rompendo le reti familiari che erano un tempo il canale principale per la trasmissione dei ricordi, accelera il processo).
Il secondo piano di lettura attiene all’uso che si fa del passato. Cioè alla sua ambigua attualità, alla sua decontestualizzazione e al consumo che, ridotto in questi termini, se ne fa nelle società contemporanee. Il passato era un tempo rigidamente spartito in due sfere scarsamente comunicanti: da una parte esisteva la sfera della memoria privata, fosse personale o di famiglia, coltivata frammentariamente da ogni individuo (non per caso proprio da lì trasse alimento al suo apparire la psicanalisi come scienza moderna) e condivisa da più ristretti nuclei comunitari di individui; e dall’altra parte una sfera pubblica, gestita dalle istituzioni. Il passato della guerra, ad esempio quello della Grande Guerra di cui quest’anno celebriamo la ricorrenza centenaria, ebbe subito, sin dal periodo bellico, due declinazioni, che ritroviamo in tutti i Paesi belligeranti. L’una privata: le lettere dal fronte, sia pure sottoposte al vaglio della censura militare, ma poi conservate gelosamente nello scrigno della memoria familiare; o i racconti dei reduci nel chiuso della cerchia parentale; o la memoria tramandata della famiglia contadina allargata (o anche della famiglia borghese: il ritratto del caduto in divisa nell’“inutile salotto”). L’altra declinazione, pubblica, ufficiale: i monumenti ai caduti in ogni piazza d’Italia, la letteratura popolare sulla guerra, le manifestazioni dei reduci con le sfilate negli anniversari, l’esibizione delle medaglie e dei gagliardetti, la guerra raccontata nei libri (a cominciare da quelli scolastici), la guerra nel cinema, la retorica pubblica della guerra. Il fascismo si impadronì subito di quel passato (che comunque era già stato manipolato in chiave di nazionalismo esasperato dai governi liberali del dopoguerra) e lo mise semplicemente in camicia nera. Un ruolo decisivo ebbero in questa operazione gli specialisti del passato (gli storici di professione dell’epoca), che si impegnarono, nelle università e sui libri scientifici, a ricostruirne i lineamenti canonici. A lungo, nel dopoguerra, la nuova storiografia democratica avrebbe stentato a rompere quell’interpretazione nazionalista della guerra (in ciò ostacolata dalla gestione di parte che per molti anni è stata fatta delle fonti militari).
Oggi questa annessione del passato a una interpretazione politica sarebbe più difficile: non impossibile, ma più complessa. Perché oggi il passato è fruito direttamente, apparentemente senza mediazione, da cerchie sempre più vaste e – soprattutto – sempre più indistinte di cittadini, non necessariamente specialisti e neanche cultori per hobby del passato. Le modalità di questa fruizione indistinta sono uno dei punti di vista che Madel Crasta addita al suo lettore. Qui sta uno dei passaggi fondamentali del libro.
Nella società dell’immagine nella quale viviamo il passato è decontestualizzato, dunque, e ridotto spesso ad icona, a brand, utilizzato per il suo valore simbolico.
Mi spiego con un esempio. Sono andato per la prima volta a visitare al Cimitero degli inglesi, a Roma, la tomba di Gramsci. Non l’avevo mai fatto, pur avendolo spesso desiderato. Ne ho avuto un’impressione fortissima. Mi è sembrato che la sobrietà della sepoltura, la sua evidente a-monumentalità, il luogo appartato e quasi nascosto (nascosto il cimitero, pur nel centro di Roma; nascosta e silenziosa la modesta tomba in un cimitero pieno di lapidi eloquenti) parlassero direttamente di Gramsci, dicessero della sua vita e del suo pensiero più di tante ricostruzioni storiografiche. Poi sono andato, a pochi passi di distanza, nel grande centro che Oscar Farinetti ha costituito per la sua Eataly, nella struttura della stazione Ostiense. E lì ho ritrovato Gramsci, ma questa volta nell'icona stilizzata più famosa, appeso sui cibi, a significarne forse l’italianità. Un Gramsci de-contestualizzato (e quindi anche inevitabilmente) ridotto alla stregua del Che con il sigaro e il basco, come è nell’immagine che viene riprodotta a milioni sulle magliette degli adolescenti di tutto il mondo.
Il rischio che corriamo, che stiamo correndo, è di una fruizione simile del passato. Madel Crasta ci dice che il rischio esiste, ma nella eterna contrapposizione tra “apocalittici” e “integrati” mi pare (mi pare: ma dovremmo introdurre delle specificazioni, distinguere sulle posizioni intermedie della forbice) preferisca schierarsi coi secondi, con tutti i rischi connessi, piuttosto che arroccarsi coi primi.
Il terzo piano riguarda quelle che chiamerei le conseguenze del progresso tecnologico, e cioè la ristrutturazione che il passato (la memoria stessa del passato) subisce nell’ambito di quel vasto e decisivo processo in atto di riscrittura dei saperi, col passaggio dalle strutturazioni gerarchiche, specialistiche e isolazionistiche delle vecchie culture (inesorabilmente verticali) a strutture nuove come sono quelle dei nostri tempi, potenzialmente mai concluse ma sempre suscettibili di nuove aperture, di tipo non più verticale ma orizzontale. Dal sapere strutturato a canne d’organo, al sapere disposto nella rete o disperso nell’intreccio infinito delle reti.
Sotto questi tre profili il libro vuol essere ed è un libro “politico” (di politica culturale, ma non solo). Non ha nulla a che fare, cioè, con l’ideologia banale, purtroppo tanto diffusa, che vede nel patrimonio culturale i pozzi inesauribili da cui estrarre petrolio (curioso che da ultimo Salvatore Settis abbia autorevolmente contestato questa visione economicistica e che, a distanza di solo poche ore, il neoministro della cultura Dario Franceschini, un leader politico moderno e non certamente banale, l’abbia riproposta pari pari nella sua prima intervista ufficiale, rilasciata al “Sole-24 Ore” poco dopo il giuramento del governo Renzi).
Sin dalla prima parte dell’ e-book Madel Crasta insiste sulle responsabilità sociali che gravitano intorno al patrimonio culturale: che non è (non è solo) questione riservata ai governi, e neanche alla competenza dei politici, ma che pertiene invece a tutte le donne e agli uomini che sentono di doversi interrogare sul proprio ruolo, sul proprio futuro, sul proprio rapporto con la società. Esiste “il popolo della memoria”, insomma, ed è protagonista della lotta democratica per controllare il passato.
Su questo concetto conviene soffermarsi. Esiste un soggetto attivo, che tende a spodestare le élite intellettuali sinora, da secoli, padrone indisturbate della gestione del passato. Naturalmente non sfuggono a Madel Crasta le differenze tra la ricerca storica, magari condotta in archivio sui documenti, e la memoria, che si affida invece al ricordo (il ricordo in sé è individuale, è caduco, è labile, è impreciso, nel tempo tende a sfocarsi e a interpolarsi con altri ricordi: dunque la memoria non è una fonte di ricostruzione scientifica della storia; serve ad altro). Ma giustamente l’autrice ci richiama a una concezione non aristocratica della cultura. Se masse prima passive si entusiasmano davanti ai bronzi di Riace – si domanda – sarà solo per la sapiente campagna condotta dai media? Per un effetto indotto di imitazione collettiva? E se su quell’effetto, comunque, nasce una confidenza prima insperata con la cultura, la confidenza con il museo non più vissuto come luogo estraneo, non si potrà costruire su quel primo input un percorso successivo?
È molto interessante la rapida rassegna che il libro contiene delle esperienze (le più varie) sinora compiute: Niccolini e l’estate romana, ma anche i giacimenti culturali di De Michelis (pur con tutti i limiti dell’una e dell’altra esperienza, specie della seconda); Jacques Lang in Francia; la nascita in Italia di una rivista come “Economia della cultura”; Veltroni e la sua idea dei beni culturali nel breve periodo del suo ministero; l’esperienza della Regione Emilia Romagna; i tentativi di Rai-Radio 3. Cosa hanno in comune tutte queste esperienze? Hanno in comune un’apertura alla collettività intesa come insieme, non più fasce “con la patente”, della fruizione del bene culturale.
Il libro passa anche in rapida rassegna i punti critici della svolta: intanto la non risolta sinergia tra un modello centralista che viene dall’Italia fascista e del dopoguerra, basato su solide (e persino “gloriose”) strutture pubbliche, e il forse disordinato ma vitale pullulare di istituzioni territorialmente decentrate, espressione delle comunità locali, spesso manifestazione di una nuova vitalità del mondo privato. Non sempre tutto quello che è statale è il male, così come tutto quel che è decentrato è il bene. Ma la tendenza, la trasformazione profonda in atto nella realtà istituzionale, non può più risolversi nella gestione centralistica, per quanto assistita da competenze d’eccellenza.
Il panorama, insomma, si popola di nuovi protagonisti. E dunque cresce anche una babele di linguaggi, una caotica concorrenza di filosofie della fruizione. È opportuno mettere ordine, un ordine diverso da quello del passato ma comunque “ordinato”? O è bene invece che i cento fiori fioriscano?
Madel Crasta è forse molto radicale nelle visioni di fondo, ma ha poi una posizione equilibrata sulle modalità per realizzarle. Sa, per lunga esperienza, com’è intricato il mondo in cui si muove. Ad esempio non esclude (anzi) un ruolo determinante, almeno nel breve periodo, del Ministero (meglio dei beni culturali, o meglio della cultura? Non è la stessa cosa). Ma giustamente chiede che le politiche centrali si intreccino con quelle territoriali senza contrapporvisi, e una politica dello Stato che tenga conto dell’evoluzione intensa che stanno attraversando le tradizionali professioni della cultura. Gli archivisti, per esempio, sono stati per generazioni allevati nella religione dell’inventario come espressione dello studio dell’istituzione: ogni istituzione iuxta propria principia, ogni ordinamento archivistico come ricaduta della prassi storica di quell’istituzione. Persino i linguaggi sono stati storicamente differenziati su questa base da quelli di altri operatori culturali. Ma ha un senso questa divisione delle parti (e delle culture specialistiche, e delle stesse formazioni professionali) quando nella grande rivoluzione in atto il tessuto istituzionale è continuamente scomposto, aggregato e riaggregato, e la stessa attività istituzionale si presenta non più nella forma dell’albero (i ministeri, gli assessorati, gli enti separati), dove le decisioni promanano dal centro per raggiungere la periferia, dall’alto per permeare di sé il basso, ma invece si formano nella simultanea dinamica orizzontale di tutte le parti dell’insieme? Se un documento “naviga” tra più soggetti, si definisce sulla rete per progressive approssimazioni simultanee di più livelli decisionali non gerarchicamente ordinati, se, insomma, scaturisce da un moto circolare, con quali criteri ne definiremo in futuro la proprietà, la natura, la titolarità prevalente?
Viene dal nuovo assetto delle istituzioni, a sua volta figlio della struttura a rete dei grandi sistemi di governo del mondo, anche una nuova “geografia” del patrimonio culturale, tutta diversa da quella sinora conosciuta: con possibilità infinite di una sua lettura. Nella fruizione, non da parte dello studioso ma da parte del “popolo della memoria”, quei nessi, quelle separazioni, quelle paratie stagne che parevano insuperabili saltano letteralmente per aria, tendono a liquefarsi.
Insomma, una rivoluzione culturale è in marcia. Si tratta di trovare le politiche adatte a non farla fallire e (forse) gli equilibri dell’ordine nuovo che ne dovrà derivare. Tocca la responsabilità collettiva di tutti, naturalmente. Ma più di tutti quella di chi nel patrimonio ci studia e ci lavora.

Riproduzione riservata