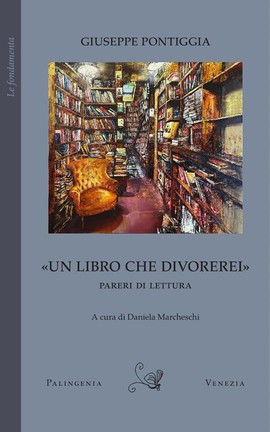Le generazioni nate successivamente al 1945, almeno in Europa occidentale, hanno avuto la fortuna di essere pressoché indenni dal coinvolgimento in eventi bellici, salvo – per alcuni Paesi coloniali – i conflitti dovuti alla decolonizzazione. Per la maggior parte dei nati dopo la Seconda guerra mondiale il conflitto armato, con la sua scia di lutti e sciagure, è stato per lo più una cosa lontana, anche se in alcuni casi fonte di un potente coinvolgimento politico ed emotivo (penso, ad esempio, al Vietnam): perfino le vicende dei recenti conflitti balcanici, geograficamente così vicini, suonavano in qualche modo culturalmente distanti e, comunque, non lasciarono segni più di tanto tangibili sui cittadini occidentali; al contrario, le generazioni precedenti, per secoli e secoli, difficilmente sfuggivano a una qualche forma di coinvolgimento personale diretto in eventi bellici. Un coinvolgimento che non necessariamente si concretizzava in una partecipazione alle attività militari, ma almeno nelle conseguenze di queste ultime: miseria, perdita dei propri beni e delle proprie case e – frequentemente – epidemie.
Non molti anni fa un noto studioso ebbe un successo editoriale notevole con il volume nel quale esponeva le sue discutibili tesi sulla “fine della storia”, al termine della Guerra fredda (F. Fukuyama, The End of History and the Last Man, New York, 1992). Nel volgere di qualche anno, la storia sembra essersi presa tutte le sue rivincite: abbiamo dovuto affrontare una pandemia che ha modificato per molti mesi, in modo radicale, le nostre vite e prodotto tanti lutti; e negli ultimi mesi è (ri)esploso un conflitto che – purtroppo – non ha alcuna caratteristica regionale, ma anzi tende a manifestarsi come sempre più globale, rievocando così quella sinistra coppia – guerra e pestilenza – che sembrava consegnata a un passato ormai remoto.
Entrambi questi eventi hanno determinato una cospicua produzione di saggi e studi, spesso instant, talvolta di qualità assolutamente scadente. Nelle righe che seguono vorrei invece soffermarmi su di un saggio di natura assai diversa, pur se indirizzato a un pubblico colto generalista e non necessariamente agli specialisti.
Emanuele Stolfi, da tempo fervente cultore, oltre che delle antichità e del diritto romani, del mondo greco in tutta la sua complessità, ha dato alle stampe un agile volumetto dal titolo Come si racconta un’epidemia. Tucidide e altre storie (Carocci, 2022).
Ormai da diversi anni, ben prima che le vicende presenti ci costringessero a ripensare a questi temi, gli storici dell’antichità (e non solo quelli) si sono aperti a considerare dati provenienti da fonti diverse da quelle che, per antica tradizione, sono di comune uso dello storico: la storia naturale ha così iniziato a divenire un documento letto non solo dallo «scienziato», ma anche dallo storico. Basti pensare ai fortunati studi di Jared Diamond, nei quali l’elemento epidemico, al pari di altre analisi relative all’ambiente, costituisce un elemento determinante dell’opera ricostruttiva. Ma, più in generale, l’aspirazione a una sorta di storia totale che consenta di giungere a una risposta davvero convincente a domande che continuano a porsi da secoli caratterizza ormai la storiografia dei nostri giorni.
Gli esempi sono numerosi, e basta citarne solo un paio, volendo rimanere nell’ambito delle epoche più antiche: penso, per il regno di Giustiniano, al volume di William Rosen, The Justinian Flea, dedicato alla crisi dell’Impero bizantino. E così, pure, merita di essere ricordato il fortunato scritto di Kyle Harper (The Fate of Rome) che – avvalendosi di nuovi dati epidemiologici e climatologici – tenta di rispondere a uno dei più antichi e complessi quesiti affrontati dagli storici nei secoli passati: le cause della caduta dell’Impero romano d’Occidente.
La domanda che si profila sullo sfondo dello scritto di Stolfi, è una delle più antiche e, al contempo, delle più controverse: a che cosa serve la storia? È, forse, essa maestra, come avrebbe detto Cicerone?
Lo scritto di Stolfi non appartiene, tuttavia, a questo filone, poiché egli non si inserisce nelle fila di coloro che tentarono di analizzare il fatto epidemico dell’antichità, tentando, ad esempio, di sciogliere l’enigma – tuttora (vanamente?) discusso – circa l’esatta natura della cosiddetta peste di Atene. Al contrario,il suo è un approccio interamente storiografico (o, se vogliamo, meta-letterario), ossia indirizzato a ricostruire non quello che accadde, ma quel che si disse essere accaduto: è proprio questo approccio, credo, a rendere il volume non solo appetibile per il lettore colto, ma più in generale stimolante per chi desideri interpretare la realtà, bella o brutta, che ci circonda e nel contempo riflettere sulla natura del rapporto che lega noi, nel presente, ai nostri predecessori, del passato più o meno remoto. Più in generale, si potrebbe dire che la domanda che si profila sullo sfondo dello scritto di Stolfi, è una delle più antiche e, al contempo, delle più controverse: a che cosa serve la storia? È, forse, essa maestra, come avrebbe detto Cicerone? Il suo studio, e la conoscenza del pensiero degli antichi, ci preparano a vivere nel modo migliore nella nostra epoca, come avrebbe probabilmente detto anche un fortunato banchiere (oltre che grande storico del mondo greco) come George Grote? Non moltissimo tempo fa anche un protagonista della finanza italiana, Franco Cingano, aveva scritto – richiamandosi a Gramsci – che il mondo classico (e dunque anche la storia antica) “è sempre vivo perché, essendo morto, è ancora capace di incarnare vitalità lungo le generazioni, testimonianza della continuità della storia e della civiltà” (in "Belfagor", 57, 2002). Nelle ultime pagine del suo scritto, Stolfi chiarisce la sua posizione sul punto, quando – con uno sguardo più pessimistico di quello di Tucidide – afferma che tornare al passato non “assicura di non ripetere gli errori commessi, o di progettare con più successo il proprio futuro”, ma ciò nonostante ci aiuta a “interrogare criticamente il nostro tempo” e “a saperlo guardare da fuori senza rimanere succubi del contingente”. Da questo punto di vista, mi pare che il lavoro di Stolfi si inscriva in un “genere letterario” che in Italia è sempre rimasto relativamente ai margini degli studi, nonostante la vicinanza di uno dei suoi maggiori esponenti – Collingwood – alla scuola dell’idealismo italiano: mi riferisco alla storia delle idee. Secondo Collingwood, ogni storia è in realtà storia delle idee, e lo studio della storia mira in realtà alla conoscenza di sé (we study history, in order to attain self-knowledge). Mi pare che, seppure all’interno di un quadro culturale di riferimento non necessariamente neoidealistico, sia proprio questo l’approccio felicemente adottato dall’autore di Come si racconta un’epidemia.
Nella prima parte del volume, l’autore chiarisce come la materia oggetto delle narrazioni che egli intende decostruire abbia una natura del tutto particolare: l’evento epidemico, infatti, ha un impatto violento sulla vita associata, “interpella il senso del vivere insieme”, la relazione con la natura e con la divinità, e – non da ultimo – mette in discussione la capacità di individuarne e analizzarne le cause e allo stesso tempo la posizione di chi, in quanto titolare dell’azione di governo della comunità, dovrebbe assicurarle salvezza e protezione. Già qui emergono i temi centrali del volume: le relazioni sociali (e la loro potenziale disgregazione), il ruolo del sapere, tecnico e scientifico (e la sua eventuale impotenza), l’azione di chi governa (e la sua adeguatezza o meno nel contrastare il fenomeno).
Per affrontare questi temi, l’autore centra la sua attenzione su di una pestilenza in qualche modo archetipica, ossia quella che colpì Atene nei primi anni della Guerra del Peloponneso e che – fra l’altro – determinò la morte di Pericle: un evento che, per una parte non piccola del pensiero politico antico, contribuì alla “degenerazione” della democrazia ateniese. Questa scelta fa sì che l’analisi di Stolfi si apra, in primo luogo, con il racconto tucidideo: un racconto per certi aspetti aspro nella sua fredda analiticità e nella sua potenza, nel quale si vede bene all’opera lo sguardo del grande storico. Uno sguardo centrato sugli effetti dell’epidemia sulla società ateniese, e sulla sua latente disgregazione, in modo del tutto analogo agli effetti di una guerra civile (stasis): sia l’una, sia l’altra si rivelano infatti cause di sovversione (o di annichilimento) delle regole; cause, insomma, di anomia. Una anomia che, peraltro, assume dimensioni totalizzanti, perché non sovverte solo la norma giuridica, ma anche quella morale e quella religiosa: è l’intera società, insomma, che viene esposta alla disgregazione, tanto più che – a rendere più fosco il quadro – interviene l’impotenza della medicina.
Come giustamente osserva Stolfi, nel suo racconto Tucidide è e rimane un sintomatologo: sintomatologo della politica così come sintomatologo della vicenda epidemica, l’approccio non cambia, tanto più che l’epidemia è essa stessa un fenomeno non solo clinico, ma sociale.
L’evento epidemico ha un impatto violento sulla vita associata, “interpella il senso del vivere insieme”, la relazione con la natura e con la divinità, e mette in discussione la capacità di individuarne e analizzarne le cause
All’analisi del racconto tucidideo, Stolfi fa seguire quella del precedente culturalmente più immediato e certo noto ad ogni greco: mi riferisco alla peste narrata da Omero nel primo libro dell’Iliade. Questo precedente narrativo mostra con forza quanto la ragion critica tucididea fosse ormai distante dal fondamento culturale condiviso degli elleni (e, del resto, anche da storici da lui non così distanti cronologicamente, ma tanto più aperti a dar spazio a narrazioni mitiche). Quasi seguendo uno sviluppo dialettico di tesi e antitesi, a Omero e Tucidide segue, nell’analisi di Stolfi, il Sofocle dell’Edipo Tiranno. Anche in questa tragedia ritorna il tema della peste, certamente ben presente all’autore e agli spettatori della tragedia, avendola essi sperimentata solo pochi anni prima. Decostruire la tragedia di Sofocle (e, a dire il vero, di tutti e tre i grandi tragediografi) non è impresa facile: sono infiniti, infatti, i passi nei quali si potrebbero leggere prese di posizione politiche, culturali, filosofiche riconducibili al dibattito culturale, così straordinariamente ricco, dell’Atene del V sec. a.C. Di certo, mi pare del tutto condivisibile l’interpretazione di Stolfi quando rileva la distanza fra la lettura del fatto epidemico data da Tucidide e da Sofocle, per la presenza così forte – nel tragediografo – della questione delle cause del morbo (assente o quasi, invece, in Tucidide), del peso del fattore religioso e di uno sguardo tutto rivolto “alle dinamiche del potere” sovrano e non a quelle più propriamente politiche, tipiche dello storico. La nostra storia delle narrazioni antiche dell’epidemia termina, quindi, con Lucrezio: apertasi con Tucidide, poi rivoltasi alle radici omeriche, indi tornata a Sofocle, si conclude fuori dal mondo greco, con la rilettura che il poeta seguace di Epicuro fa, ancora una volta, della peste di Atene. Qui il morbo assume una valenza che pare allo stesso tempo tragica e filosofica, nel momento in cui il suo accadere testimonia dell’assenza di qualsiasi forma di giustizia divina. La rilettura di Lucrezio, che reinterpreta Tucidide aggiungendovi le tinte fosche che diverranno caratteristiche della poesia e della tragedia latina della prima età imperiale, diventa così una riflessione sulla condizione umana e sulla sua assoluta fragilità, dove il male è un fenomeno naturale, privo di ogni legame con il divino, che proprio per questo diviene monito terribile che incita all’emancipazione dalla debolezza della propria natura per via di un percorso verso la vera, filosofica saggezza.
Il saggio di Stolfi si muove dunque fra più piani. Uno è costituito dalle relazioni culturali, letterali e filosofiche fra gli autori di cui egli si occupa: è storia di una narrazione, quella della peste, esemplificata nell’episodio ateniese, attraverso i secoli, e di come la narrazione di un evento che fu centrale nella storia del mondo greco abbia assunto di volta in volta caratteri e sfumature diverse fino a diventare, davvero, un archetipo carico di significati, sganciandosi in realtà dal momento, dal fatto storico, dalla propria genesi. D’altro canto, è allo stesso tempo uno studio su alcuni temi anch’essi archetipici, che sono coinvolti in quella narrazione e nelle sue rielaborazioni: il rapporto fra uomo e divinità, fra uomo e natura, e di conseguenza anche sulle facoltà o possibilità umane di piegare o sconfiggere la natura (attraverso la medicina). Del resto, si può ben immaginare quale fosse lo sconcerto degli ateniesi in quel torno di anni, quando la medicina pareva aver dimostrato come dietro i prodigi non vi è la divinità, ma il fatto naturale, e al tempo stesso quella techne si rivelava impotente di fronte al flagello, sia nel comprenderlo appieno che nel curarlo, ridando così fiato alle antiche tesi per le quali la pestilenza è flagello divino, punizione di una colpa. Ma non vi è solo questo, poiché nelle narrazioni esaminate da Stolfi altro elemento centrale è il comportamento del governante, la sua capacità di reazione e di mantenere la compagine sociale al riparo dal caos e dall’anomia.
Infine, come osserva acutamente l’autore, c’è una assenza, almeno a paragone di riflessioni ed esperienze moderne: manca del tutto, nelle narrazioni considerate, l’elemento economico. Il che sottolinea bene come il dialogo con l’antico sia fatto di assonanze e dissonanze, analogie e differenze. Una storia del come si sono raccontate e interpretate le epidemie nei secoli costituirebbe certamente una pietra miliare nella storia delle idee, ma è – credo – qualcosa al di là della portata di un singolo studioso, a maggior ragione nell’attività frenetica imposta dai tempi moderni: credo anche, però, che lo scritto di Stolfi possa costituirne un primo, significativo, tassello.

Riproduzione riservata