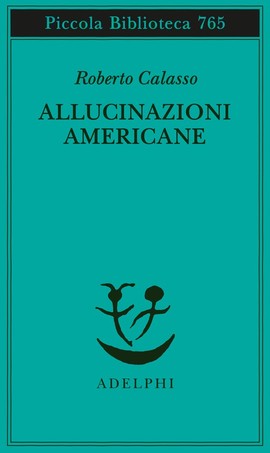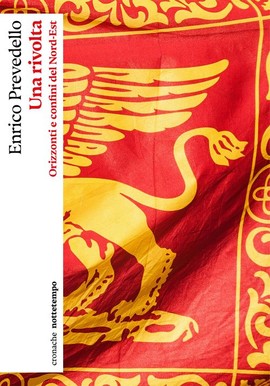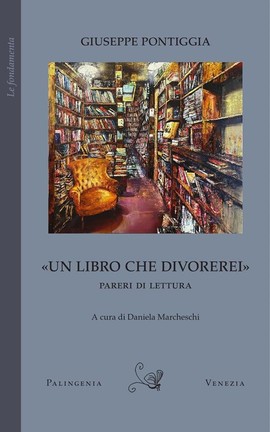«Davanti all’ingresso dell’ippodromo c’era un podio lungo e basso su cui centinaia di donne, vestite da angeli, con vesti bianche e grandi ali sulla schiena, suonavano lunghe trombe dai riflessi dorati». È lo spettacolo che si trova davanti Karl Rossmann, il protagonista del romanzo America di Franz Kafka, una volta arrivato a Clayton, dove si tengono i colloqui per quanti sono interessati a collaborare con il Teatro di Oklahoma. All’inizio del capitolo, c’è un cartellone pubblicitario che, all’angolo della strada, recita «Il grande Teatro di Oklahoma vi chiama! Vi chiama solo oggi, solo una volta! Chi perde l’occasione adesso la perde per sempre!», facendo intravedere al protagonista la possibilità di un futuro.
Ma torniamo alle donne angeliche che si presentano alla vista di Karl, appena uscito dalla metropolitana di Clayton. Secondo Roberto Calasso, autore di Allucinazioni americane (Piccola Biblioteca Adelphi, 2021), quello spettacolo è un omaggio a Busby Berkeley, genio del musical e suo «nume tutelare», capace di creare coreografie sensazionali e ammalianti, espressione di un genere che ebbe larga fortuna nella prima metà del Novecento. Quella visione celestiale ci coinvolge - insieme al protagonista - e ci innalza (proprio come quelle donne, poste su basamenti fino a due metri di altezza, nascosti dalle lunghe vesti). «Era un clangore confuso, le trombe non erano in accordo. […] Questo però non disturbò Karl, accrebbe piuttosto la sua convinzione che fosse una grande impresa». Quella «grande impresa», in fondo, è il cinema, con la sua capacità di creare atmosfere fuori dal mondo, che rapiscono lo spettatore, sospendendolo tra la dimensione a lui famigliare, concreta, e quella effimera su pellicola; la sua vita, da un lato, e quella raccontata su celluloide, dall’altro.
Calasso lo dice apertamente: è convinto che il cinema sia il «materiale metafisico per eccellenza». Una dimensione che si intreccia all’allucinazione, un coinvolgimento quasi totale, nel buio della sala. In questa dimensione onirica, i pop corn sono lì a ricordarci la nostra natura (anche) corporea. Il cinema, del resto, rimane ancorato alla temporalità, in quanto esperienza che occupa un tempo misurabile nel mondo della vita. Così come il cinema rivendica una sua spazialità: necessita di un luogo fisico in cui manifestarsi, con un suo odore e le poltroncine rosse. Il cinema è un altrove, insomma, ma non così tanto lontano da noi. Questa vicinanza-lontananza la si coglie leggendo le pagine di Kafka (le donne angeliche a pochi passi dalla stazione), pensando ai cinema nelle vie delle città («deviando di pochi metri dalla strada, dove si svolge la vita “normale”, lo spettatore entra in un luogo di tenebra, dove si distaccano le immagini su un fondale lattiginoso», scrive Calasso), ricordando il cortile di Rear Window, il luogo dove si svolge l’intera vicenda ma che lascia intravedere - attraverso uno stretto passaggio a sinistra dello schermo - il mondo «vero». "Chi entra in un Hitchcock […] mette piede in luoghi autosufficienti, che tendono a risucchiare tutto in sé. Ci possono poi essere anche altre ragioni di costante, rinnovato stupore. Può essere uno stupore non solo estetico, ma speculativo"Se c’è un regista che ci permette di cogliere la dimensione metafisica del cinema è, del resto, secondo Calasso, proprio Alfred Hitchcock. «Chi entra in un Hitchcock […] mette piede in luoghi autosufficienti, che tendono a risucchiare tutto in sé. Ci possono poi essere anche altre ragioni di costante, rinnovato stupore. Può essere uno stupore non solo estetico, ma speculativo. O meglio: uno stupore estetico “perché” speculativo». Film come Vertigo o Rear Windows «all’usuale intreccio di delizie e terrori, sovrappongono una dimensione metafisica». Caratteristica, questa, che Eric Rohmer e Claude Chabrol avevano già sottolineato nella loro opera dedicata al regista (edita per la prima volta nel 1957 e in Italia pubblicata da Marsilio): «Se c’è un film di Hitchcock per il quale il termine metafisica può essere citato senza timore, ebbene questo è proprio Rear Window».
Quest’ultimo e Vertigo sono i due film, rispettivamente del 1958 e del 1954, attraverso i quali la riflessione di Roberto Calasso prende forma nelle pagine. Li definisce «film gemelli» in quanto accomunati dallo stesso attore, James Stewart, che interpreta in entrambi un personaggio che svolge un «mestiere inquisitivo» (fotoreporter o agente di polizia), anche se al momento della narrazione è impossibilitato a svolgerlo, in quanto immobilizzato in seguito a un incidente oppure dimesso a causa dell’acrofobia. Entrambi, inoltre, fanno i conti con una fidanzata bionda (vedi alla voce «biondità» nel cinema hitchcockiano e - per una riflessione del regista sulla femminilità - rimando all’articolo “Elegance Above Sex” pubblicato su Hollywood Reporter il 20 novembre 1962).
La lettura del maestro del brivido che propone Calasso è dentro e fuori la mente, dentro e fuori il cinema, dentro e fuori Hitchcock. Due itinerari, in particolare, trovo degni di nota. Il primo è quello che apre il saggio, a partire da una parola: «figmentum», ossia l’immagine mentale, inafferrabile, irreale, ma seducente. In Vertigo, «figmentum» è Madeleine, la moglie di Elster, che vediamo incarnata da Judy (prima perché il piano dell’amante e assassino possa funzionare, poi - nella seconda parte di film - per volontà di Scottie). Il protagonista sarà sentimentalmente travolto da questa donna, tanto da non rassegnarsi alla sua morte e tanto da vincere la sua paura dell’altezza e del vuoto. In fondo, l’amore che Scottie prova per la presunta Madeleine («I loved you so, Madeleine») è l’unico sentimento vero in un susseguirsi di maschere. Il «figmentum» ha vita propria. È un’illusione che trascende il reale, resa nel film con i continui rimandi al colore verde che accompagnano il personaggio e le atmosfere annebbiate cariche di mistero. Oppure i capelli biondi della donna, raccolti in uno chignon, il quale rimanda alla spirale dei titoli di testa e, ancora, alla vertigine.
Di Rear Window, invece, Calasso fornisce un’interpretazione maturata a partire dalla filosofia orientale, convinto che quel film sia una metafora dell’Occidente e che ci occorra uno sguardo estraneo per comprenderci più a fondo. Il fotografo che osserva la vita nel cortile sta all’assassino come, nei Veda, l'ātman (il Sé) sta all’aham (l'Io, inteso come soggetto in divenire). I due personaggi antagonisti, il fotoreporter Jeff e l’omicida Lars Thorwald, sarebbero quindi molto più vicini di quanto si immagini, addirittura parti conflittuali in uno stesso corpo, portati al contrasto nel tentativo di costruire la propria identità. Il film, secondo questa prospettiva, mette in scena una lotta tra il Sé che osserva e l’Io che mette in pratica il sacrificio, «azione per eccellenza» che in questo caso si identifica con l’assassinio. La lotta si conclude, infine, con Jeff che abbaglia con il flash Thorwald, ossia il Sé che «tenta di paralizzare con la sua luce interna la rivolta dell’Io».
Il cinema di Hitchcock, in virtù di questo suo carattere metafisico, si presta a continue interpretazioni. C’è da dire che il regista britannico attribuiva grande importanza agli elementi sulla scena, che diventano così simboli e che, per forza di cose, rimandano ad altro. Ne deriva una rete di significati, un’intelaiatura intrisa di possibili riferimenti. Gilles Deleuze, ne L’immagine-movimento, scrive a tal proposito: «Nella storia del cinema Hitchcock appare come colui che non concepisce più la costituzione di un film in funzione dei due termini, il regista e il film da fare, ma in funzione di tre termini, il regista, il film e il pubblico che deve entrare nel film, o le cui reazioni devono far parte integrante del film». Deleuze definisce Hitchcock "come colui che non concepisce più la costituzione di un film in funzione dei due termini, il regista e il film da fare, ma in funzione di tre termini, il regista, il film e il pubblico che deve entrare nel film"D’altronde, è lo stesso Hitchcock a sottolineare come il pubblico «debba» partecipare al film, lasciandosi coinvolgere. «Credo che il ritmo di un film stia tutto nel tenere occupata la mente dello spettatore», spiega durante una lezione alla Columbia University nel 1939. Il cinema deve essere un’esperienza che cambia, trasforma lo spettatore. «Io gioco con il pubblico. Gli faccio trattenere il fiato, lo sorprendo, lo scuoto» (sempre Hitchcock).
In conclusione, torniamo a Rossmann, nel mezzo del romanzo di Kafka. Il protagonista, dopo la vista del coro di donne, si domanda dove si svolgano i colloqui per il personale. Una signora col passeggino, accanto a lui, gli suggerisce di entrare nell’ippodromo per chiedere informazioni.
«“Sì”, disse Karl, “ma dovrei attraversare il podio passando fra gli angeli”. “È così difficile?”, disse la donna». Difficile forse no, la risposta che verrebbe da consigliare al personaggio di Kafka. Certamente, però, quel «passare attraverso» potrebbe causare allucinazioni.

Riproduzione riservata