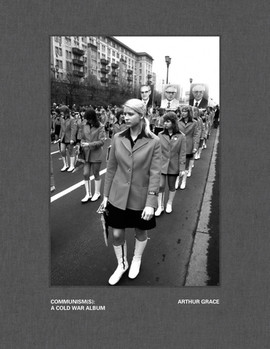Questo articolo fa parte dello speciale C'era una volta l'Urss
Arrivata a Mosca nei primi anni Ottanta per uno dei frequenti scambi accademici tra la mia università e istituti di ricerca russi, trovai ad attendermi all’aeroporto – oltre a una piccola delegazione ufficiale – alcuni miei ex laureati. Gran festa.
La più importante era Teresa, interprete di Prodi durante la sua presidenza all'Iri, la quale addirittura disponeva di autista e macchina; vi era poi il giovanissimo diplomatico dell’ambasciata in veste privatissima, e ricercatori con borse dell’Orientale di Napoli venuti a studiare sul campo il «socialismo realizzato».
Teresa, esperta del saper fare in terra sovietica, liquidò la delegazione e ci ritrovammo liberi e contenti tra noi. Il mio primo appuntamento era al mattino, all’Istituto. Mi chiesero del programma, che comprendeva alcuni punti immutabili: una relazione sullo stato degli studi sull’Urss nella mia Università e in generale in Italia, una visita al museo della «Grande guerra patriottica», una serata al Bolscioi, una cena ufficiale con interminabili brindisi e soprattutto un viaggio a Leningrado o a Kiev, ospiti del corrispondente Istituto.
Quella volta era programmato Kiev. A cena, al riservatissimo ristorante georgiano prenotato grazie al diplomatico, discutemmo a lungo del rapporto tra russi e ucraini. Volevo le impressioni di chi viveva a contatto con gli uni e gli altri.
Sapevamo che i baltici, i polacchi e gli ungheresi mordevano il freno, sentendosi per cultura e storia ben superiori agli ex contadini e operai che con la forza avevano imposto il loro sistema, in economia e in politica. Ma gli ucraini?
Sapevamo che i baltici, i polacchi e gli ungheresi mordevano il freno, sentendosi per cultura e storia ben superiori agli ex contadini e operai che con la forza avevano imposto il loro sistema, in economia e in politica. Ma gli ucraini? Erano anch’essi ex contadini e i sovietici avevano industrializzato il loro Paese, parlavano russo e ormai usavano la loro lingua quasi come un dialetto in famiglia. I matrimoni misti erano diffusi. Gli intellettuali con cui si era in contatto non si distinguevano come russi o ucraini. E poi gli ucraini erano 40 milioni e il loro territorio era un gran pezzo di Urss. Questa era la versione corrente, che invece i miei giovani amici ridimensionarono pesantemente.
Cominciarono con il definire ancora «infidi» gli ex contadini ucraini, figli e nipoti di piccoli proprietari, spossessati dalla collettivizzazione e resi nemici implacabili, che si erano ribellati ed erano stati formalmente integrati solo dopo una terribile carestia. All’arrivo dell’esercito tedesco erano andati loro incontro con pane e sale, avevano costituito una forza militare di appoggio a quella nazista, che avevano aiutato nella caccia e nello sterminio degli ebrei locali, odiati come nell’Est Europa, e poi dopo il 1917 avevano preso ad assimilare qualsiasi ebreo con qualsiasi sovietico.
Continuarono poi illustrandomi la situazione dell’epoca, che era cambiata per quel che riguardava studenti, intellettuali, mogli o mariti di russi, formalmente uguali ma che si lamentavano, in privato, di essere considerati sempre un gradino sotto «ai veri russi». Chiesi perché. La causa era che i politici russi continuavano a non fidarsi, nonostante il segretario generale del Pcus fosse l’ucraino Brezhnev e il precedente fosse stato Khrushcev, così legato alla sua terra da regalarle la Crimea.
L’esperienza del pane e sale ai nazisti continuava a pesare soprattutto nel rapporto con la gente di campagna. Nelle tante fabbriche costruite, negli stabilimenti militari, gli operai e i tecnici erano ormai di seconda generazione, e molti aspiravano a fare carriere politiche, a inserirsi nell’apparato del potere.
Quando infine arrivai a Kiev, la sua bellezza, la cordialità degli ospiti, il pane e la frutta più buoni del mondo mi convinsero che i miei giovani amici napoletani erano stati troppo pessimisti. Poi iniziò il seminario ufficiale e intorno al tavolo vi erano sedie vuote che imbarazzavano visibilmente chi ci aveva invitato. Finalmente si aprì la porta e le sedie si riempirono. Il direttore dell’Istituto prese la parola: «Comincio con il ringraziare i colleghi che vengono da lontano perché ci hanno concesso di far alzare dal letto i nostri ricercatori locali che siamo convinti daranno finalmente un contributo». Testuale.
Quando la parte ufficiale dell’incontro ebbe termine, i ricercatori ucraini ci "adottarono", felici dell’opportunità di farci mille domande e di mostrarci luoghi della città solitamente esclusi ai turisti occidentali
Quando la parte ufficiale dell’incontro ebbe termine, i ricercatori ucraini ci «adottarono» e ci portarono in giro e chiacchierarono felici dell’opportunità di farci mille domande e di mostrarci luoghi della città solitamente esclusi ai turisti occidentali. Il tasto politico su cui tornavano ogni momento era che i dirigenti dell’Istituto e i russi in generale li consideravano cittadini sovietici di categoria inferiore, mentre loro si ritenevano di categoria superiore. Insomma, dal punto di vista culturale il dialogo era difficile, per quello politico vi era la solita divisione tra chi lo rifiutava e chi era più propenso a compromessi.
Lasciai l’affascinante Kiev cercando una qualche risposta a tanta diffidenza e negli incontri con i soliti amici, nelle chiacchierate nelle loro case accoglienti, affrontai la questione cominciando dall’Ucraina. Non erano solo gli ucraini – mi spiegarono – ad avere un sentimento di sufficienza verso chi comandava in Urss, ma ancor più i polacchi, gli ungheresi e gli altri popoli all’interno della sfera di influenza sovietica. Il motivo principale stava nell’emarginazione degli intellettuali.
Mi ricordarono che «alla fine degli anni Venti il partito si è convinto che operai e contadini dovevano dimostrare di poter fare a meno di coloro che li avevano sempre comandati. Di coloro che pensavano, che avevano dubbi, che credevano di poter contestare le scelte del partito. Gli intellettuali andavano tenuti sotto controllo, mentre un nuovo ceto dirigente di estrazione popolare sarebbe stato in grado di realizzare il socialismo». Se all’epoca in Russia una tale scelta ideologica si poteva legare al ricordo del ’17, nella realtà l’egemonia popolare imposta ha fatto durare l’esperimento sovietico 74 anni.
L’estraneazione degli intellettuali, la diffidenza e il controllo cui erano sottoposti, era sofferta dai miei amici come una misura contro natura, che prima o poi doveva essere superata poiché le società si reggono sulle idee che solo gli intellettuali sono in grado di proporre. E ancor più nel primo caso di realizzazione del socialismo. E del resto la residenza di Lenin allo Smo’lnyj, nei primissimi mesi della rivoluzione, era composta da tre piccoli ambienti: nell’uno vi era la scrivania dove scrisse il decreto Pace e terra, nel secondo un letto da campo, nel terzo un gran bel pianoforte, necessario a quell’intellettuale rivoluzionario.

Riproduzione riservata