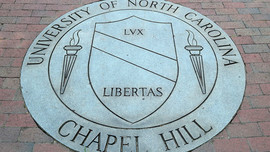Questo articolo fa parte dello speciale La pandemia degli altri
Le scuole dell’infanzia, in Norvegia, sono state riaperte la scorsa settimana e oggi, lunedì 27 aprile, è toccato alle scuole primarie: le classi 1-4 tornano in aula dopo sei settimane di pausa forzata. L’emozione è palpabile ed è come se fosse il primo giorno di scuola per tutti. Un rientro speciale su cui genitori e bambini sono già stati informati: saranno infatti avviate nuove prassi e nuove routine. Le entrate da ora saranno scaglionate, così come le uscite; i bambini saranno divisi in sottogruppi e sarà assicurato, per quanto possibile, il distanziamento spaziale. È la notizia del giorno, una notizia che molti temevano e altri attendevano con trepidazione.
Leggo commenti contrastanti anche sulla stampa internazionale e ricevo messaggi da parenti e amici, curiosi di sapere quale sia la mia opinione a riguardo. Ma io non sono molto sorpresa – penso –, prevedevo che le cose sarebbero andate così: la scuola è stato l’ultimo settore a chiudere e oggi è il primo settore ad aprire. Anzi – rifletto – le porte di questa istituzione non sono mai state del tutto chiuse nella capitale. Le scuole hanno continuato ad accogliere non solo i figli dei lavoratori nei settori essenziali, ma anche gli studenti in condizione di maggiore fragilità.
Quali saranno le conseguenze in termini sanitari della riapertura delle scuole primarie è ancora incerto, soprattutto a Oslo. Il dibattito pubblico è acceso, ma per ora pare prevalere l’opinione che le esigenze educative e di socializzazione dei più giovani non possano essere ulteriormente sacrificate. Che poi – penso – le esigenze dei minori non sono state nemmeno così sacrificate. Ricordo la conferenza stampa che la premier, il ministro della Salute e il ministro dell’Istruzione avevano tenuto di fronte a una platea curiosa di bambini, un paio di giorni dopo la chiusura delle scuole: i più giovani erano stati invitati a contenere le loro frequentazioni e spostamenti, ma allo stesso tempo erano stati anche rassicurati sulla possibilità di continuare a frequentare un paio di amici su base stabile.
Vivo da due anni in Norvegia e ammetto che alcuni aspetti del sistema di Welfare mi hanno deluso rispetto alle aspettative che nutrivo, ma se c’è un tratto culturale e istituzionale che ancora continua a sorprendermi è quello del rapporto del mondo adulto con l’infanzia.
All’inizio del lockdown, però, queste e altre disposizioni mi erano apparse tutt’altro che rassicuranti. Come molti altri italiani all’estero, vivevo in una sorta di discrasia temporale e avevo giudicato troppo deboli e tardive le prime misure di contenimento. Era già il 12 di marzo e la Norvegia registrava la sua prima vittima, mentre la furia del virus era già inarrestabile in Lombardia; a pochi giorni mi sarebbe arrivata la notizia di mio padre contagiato e ricoverato. Non vedevo ragioni per cui la curva dei contagi dovesse magicamente appiattirsi in Norvegia senza una limitazione radicale della socialità e degli spostamenti.
Le cose non erano iniziate bene qui, proprio per niente. L’infezione era partita come un’epidemia di ignari sciatori di ritorno da un focolaio dichiarato con colpevole ritardo, quello di Ischgl, in Austria. A metà marzo la Norvegia contava un numero di contagiati per abitante preoccupante e un’alta percentuale di personale sanitario in quarantena.
La rilevanza della crisi e dell’eccezionalità si poteva certo comprendere da alcune misure adottate repentinamente: la Norvegia è stata uno dei primi Paesi a chiudere di fatto le frontiere e ad affidare pieni poteri, chiesti e subito concessi, alla premier in questa fase di gestione dell’emergenza. E poi, in piena stagione sciistica, il divieto di pernottare nella Hytta (le case di villeggiatura), un autentico shock per i norvegesi – chi conosce la cultura locale potrà ben capire. Ma i comportamenti quotidiani delle persone mi sembravano ancora in pieno contrasto con la drastica riduzione delle libertà individuali decise in Italia. Un numero di runners che a me pareva inaudito affollava i parchi cittadini, perché si veniva invitati a rafforzare il proprio sistema immunitario con almeno una mezz’ora di attività sportiva all’aperto. Nessuno che indossasse una mascherina in supermercati che, comunque, mi apparivano affollati. La notizia dei primi colleghi e amici contagiati e l’ansia di essere stata io stessa l’origine dell’infezione al ritorno da un viaggio in Nord Italia, giusto pochi giorni prima dello scoppio dell’epidemia.
Invece, per ragioni che solo solide indagini epidemiologiche potranno ricostruire nel corso dei prossimi anni, il drammatico conteggio dei ricoverati e dei deceduti non appare evolvere in modo significativo in Norvegia. Ad oggi, si contano meno di 200 decessi in tutto il Paese e poche centinaia di pazienti ospedalizzati. Senza alcuna pretesa di esaustività, posso solo limitarmi a indicare, in ordine sparso, qualche ipotesi che mi pare ragionevole. L’età della popolazione colpita nella fase iniziale – giovani e famiglie di ritorno dalle località sciistiche. Un distanziamento sociale fra generazioni che è dato di fatto, non solo fra adulti e anziani, ma anche fra giovani adulti e adulti (sono pochi gli studenti universitari a convivere con i propri genitori). Una strategia sanitaria appropriata alle modalità di propagazione dell’infezione, con un basso ricorso all’ospedalizzazione nella sua fase iniziale e un isolamento domiciliare efficace. Una densità abitativa contenuta, anche nella capitale di Oslo. Un inquinamento atmosferico sotto i livelli di guardia, anche nelle aree urbane. Strumenti di Welfare adatti a compensare le perdite subite dalle attività produttive non essenziali sospese. Una terziarizzazione avanzata dell’economia che ha consentito un passaggio all’homeoffice indolore e immediato, almeno per una consistente parte della popolazione.
Ma anche la realtà norvegese presenta alcune ombre, perché pure questo ricco ed “equo” contesto è attraversato da contraddizioni profonde, che la crisi sanitaria sta evidenziando e potenzialmente amplificando. Se infatti all’inizio dell’emergenza l’infezione sembrava essere prerogativa di ceti sociali privilegiati (gli sciatori di ritorno dalle Alpi) ora invece sembra propagarsi più velocemente fra le fasce sociali più deboli e nelle aree urbane meno privilegiate. Molti dei nuovi malati sono infatti lavoratori del terziario meno avanzato, prevalentemente immigrati di prima generazione, rifugiati, tassisti, addetti alle pulizie, addetti alle vendite, che più difficilmente possono godere del privilegio di un homeoffice o di una abitazione che consenta un efficace isolamento domiciliare dei positivi. Una disuguaglianza sanitaria che si innesta su una preesistente disuguaglianza sociale. Gli equilibri sono infatti fragili anche in Norvegia e non è detto che questa prima vittoria sul virus sarà alla fine una vera vittoria per tutti.
:: La pandemia degli altri :: Parigi [Francesca Barca] / Barcellona [Steven Forti] / Bruxelles [Eleonora Medda] / Philadelphia [Massimo Faggioli] / Berlino [Fernando D’Aniello] / Tirana [Stefano Romano] / Amsterdam [Maria Panattoni] / Nur-Sultan [Stefano Raimondi] / Essen [Pasquale Guadagni] / Istanbul [Filippo Cicciù] / Umeå [Simone Scarpa] / Mosca [Loris Marcucci] / Bristol [Iacopo Di Girolamo] / Lugano [Eleonora Failla] / Zagabria [Giovanni Vale] / Lisbona [Simone Tulumello] / Toronto [Nicola Melloni] / Washington DC [Lorenza Pieri] / Leiden [Adriano Martufi] / Melbourne [Chiara De Lazzari] / Buenos Aires [Gioia Greco] / Okinawa [Eugenio Goi] / Maputo [Andreea R. Torre, Alessio Cangiano] / Chapel Hill [Serenella Iovino] / Londra [Elena Besussi] / Oslo [Roberta Cucca] / Rio de Janeiro [Gustavo Siqueira]

Riproduzione riservata