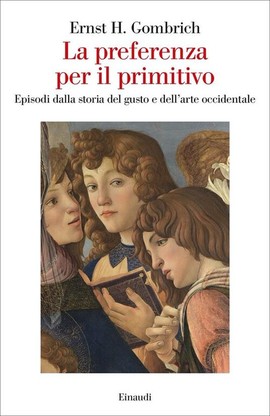Con il nome di «processo alla Resistenza» si indica l’attività giudiziaria avente per oggetto atti compiuti da partigiani sia durante sia dopo la guerra, che si dispiegò fondamentalmente fra il 1948 della sconfitta elettorale del Fronte popolare e dei disordini consecutivi all’attentato a Togliatti e il 1953, anno in cui una nuova amnistia concedeva l’indulto «per i reati politici e i reati inerenti a fatti bellici, commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate» fra l’8 settembre 1943 e il 18 giugno 1946. Fu un’attività molto intensa, anche brutale e rozza, che coinvolse molte migliaia di ex partigiani. E già allora fu intesa quale appunto era: un generale «processo alla Resistenza».
Ora la prima cosa che va sottolineata nel saggio di Michela Ponzani intitolato Processo alla Resistenza. L’eredità della guerra partigiana nella Repubblica 1945-2022 (Einaudi, pp. 232) è il suo ambito cronologico, che arriva all’oggi. La Resistenza è un’imputata a vita; non ha mai cessato di essere messa in stato d’accusa, non più nelle aule giudiziarie, ma nel discorso pubblico. Anche l’Antiresistenza ha la sua «vulgata».
Pure i fascisti ebbero i loro processi, ci mancherebbe, ma secondo una parabola alquanto diversa. Dopo una primissima fase, a ridosso della Liberazione, la giustizia fu amministrata secondo leggi ad hoc da Corti d’assise straordinarie che irrogarono numerose condanne, anche a morte. Sopravvenne poi nel giugno del 1946 l’amnistia Togliatti, di cui beneficiarono in prevalenza i fascisti; nel 1947 i procedimenti furono passati alle Corti d’assise ordinarie e le commissioni di epurazione furono sciolte con un bilancio assai magro. Divenuti magistrati della Repubblica, i magistrati del Ventennio affrontarono i processi per crimini fascisti con una benevolenza impudente, spesso annullando in appello condanne emesse in primo grado, come è raccontato qui dalla Ponzani o, per fare solo un altro esempio, dal saggio di Cecilia Nubola sulle Fasciste di Salò che documenta le piroette argomentative dei giudici per negare ai crimini commessi quella qualifica di «sevizie particolarmente efferate» che sbarrava l’accesso all’amnistia. Si può dire che il «processo al fascismo» trovò il suo coronamento simbolico nel 1950, quando il maresciallo Rodolfo Graziani fu condannato a 19 anni di carcere e rimesso in libertà quattro mesi dopo, in tempo per diventare presidente onorario del Msi.
Al contrario di quanto accadde ai fascisti, a cui non fu lesinata indulgenza, i partigiani furono perseguiti con durezza
Al contrario di quanto accadde ai fascisti, a cui non fu lesinata indulgenza, i partigiani furono perseguiti con durezza. Già con una specie di controepurazione vennero largamente espulsi dal corpo dell’amministrazione, poi furono chiamati a rispondere di atti senza veramente distinguere quelli ante e post Liberazione. Complice in questo la difficoltà reale di riconoscere legittimità, in assenza di legislazione ad hoc, agli atti di una guerra per definizione irregolare come quella partigiana. I fascisti repubblicani poterono farsi scudo del codice di guerra, in quanto forze regolari – sedicenti regolari, naturalmente, essendo forza armata di uno Stato farlocco. In tribunale, e purtroppo in una non trascurabile quota dell’opinione pubblica, i partigiani erano viceversa dei fuorilegge. E in senso letterale lo erano, loro stessi ne avevano la consapevolezza: si leggano a riprova le splendide pagine che Roberto Battaglia scrisse nel 1945 circa il problema della giustizia partigiana: l’onere del fuorilegge che, senza uno Stato che lo legittimi, si fa legislatore e si assume la responsabilità del dare la morte.
La stessa acribia impiegata a effettuare il downgrading delle sevizie particolarmente efferate dei fascisti, la magistratura la impiegò con larghezza a non riconoscere quali atti di guerra le azioni dei partigiani, come è testimoniato dai casi studiati da Michela Ponzani su una massa ingente di carte processuali.
Di sicuro in questo «processo alla Resistenza», che vide il suo acme nei primi anni del centrismo e dell’avvio della Guerra fredda, ebbe un peso rilevante la stretta associazione fra Resistenza e comunismo. Associazione che aveva ovviamente una sua ragione concreta, ma che fu anche favorita dalla determinazione con cui il Pci, a scopo di autolegittimazione nazionale, si intestò la lotta di liberazione. Merita ricordare che l’Anpi, fondato nel 1944 dal Cln come organismo unitario, proprio per essere stato monopolizzato dal Pci già quattro anni dopo subiva la secessione dei cattolici e dei militari, che si riunirono nella Fivl, e nel 1949 quella degli ex azionisti e dei socialisti, che fondarono la Fiap. «Questo accaparramento e questo patrocinio dei comunisti» – scrisse Panfilo Gentile in un mirabile articolo del «Mondo» (7 maggio 1949) – «non potevano non riuscire compromettenti per la Resistenza, e la identificazione, per quanto abusiva, tentata tra Resistenza e comunismo non poteva non rimbalzare sulla Resistenza tutte le avversioni che si erano venute accumulando contro il comunismo». Ma, continuava Gentile, non si trattava solo di questo: se la Resistenza aveva perduto il suo prestigio nella coscienza del Paese era per «un fenomeno positivo di favoreggiamento verso l’Antiresistenza». Dall’amnistia alla restituzione dei pieni diritti civili, alla formazione di partiti neofascisti, a una consistente solidarietà in ambienti politici e finanziari, «gli “ex-salottardi” dal rango dei reprobi sono saliti a quello dei favoriti».
In questo "processo alla Resistenza", che vide il suo acme nei primi anni del centrismo e dell’avvio della Guerra fredda, ebbe un peso rilevante la stretta associazione fra Resistenza e comunismo
Molti anni dopo, nel 1995, in un articolo di «Liberal» che celebrava lo sdoganamento berlusconiano della destra, un intellettuale ex missino, Giano Accame, invitava gli ex camerati a uscire dalla «lunga stagione della mitomania e del rancore» ricordando che negli anni Cinquanta le condizioni di emarginazione erano state assai più dure a sinistra che a destra. Rispetto alla sinistra, la destra «per tutti gli anni Cinquanta ha goduto di condizioni ambientali al confronto invidiabili: rapporti abbastanza buoni con le strutture dello Stato, ancora piene di funzionari, ufficiali, magistrati e professori filofascisti e con la Confindustria».
È vero che dopo il governo Tambroni e i fatti di Genova nel 1960 e più tardi l’avvento del centrosinistra la Resistenza trovò, per dir così, maggiore accredito istituzionale. Non cambiò tuttavia quella sindrome dell’assedio che almeno fino agli anni Novanta avrebbe dominato negli ambienti partigiani ripercuotendosi in una versione della guerra di liberazione irrigidita dai tabù, primi fra tutti quello di riconoscerla come guerra civile e quello di affrontare il tema delle violenze post Liberazione. Ma del superamento di quei tabù, operato da storici legati agli istituti della Resistenza, all’apertura del nuovo secolo si sarebbero meglio giovati i lettori di Giampaolo Pansa: in sintesi, in anni che hanno conosciuto anche una vivace corrente di anticomunismo postumo, ne è uscita riconfermata la «vulgata» di una Resistenza comunista e sanguinaria.
Continua dunque il processo, anche se la sentenza è già depositata: fine pena mai.

Riproduzione riservata