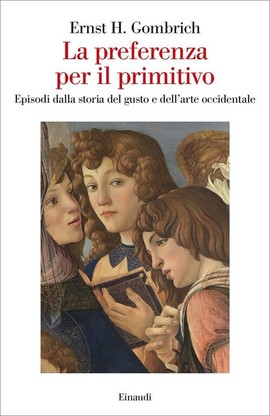Malgrado entusiastiche rassicurazioni in quarta di copertina, La preferenza per il primitivo (trad. it. Einaudi, 2023) di Ernst Gombrich, apparso nel 2002 in edizione inglese e tradotto solo di recente da Einaudi, non è un saggio all’altezza di Arte e illusione o Norma e forma, né, tantomeno, la sua stesura induce Gombrich a un’autoriflessione retrospettiva. Interessi, presupposti e irritazioni sono gli stessi, in Preferenza per il primitivo o in Arte e illusione: al punto che questa ricerca tarda, avviata sul finire degli anni Cinquanta ma editata da Gombrich poco prima di morire, diviene comprensibile solo a partire dall’ultradecennale polemica gombrichiana contro gli orientamenti espressionistico-astratti e il ready-made. Polemica che, se poteva risultare attuale in Arte e illusione, apparso nel 1960, difficilmente risulta tale ancora a distanza di mezzo secolo, venuti meno da tempo i protagonisti e trapassata la stagione del rinnovamento postbellico.
Con ordine. Il saggio muove dall’ostilità per gli esiti novecenteschi della «regressione» e si propone, per circa due terzi del suo svolgimento, come indagine «psicologica» sulla «preferenza» europeo-moderna per il «primitivo»: cioè il semplice, l’incorrotto, il posato e grandioso. In termini storici: indaga la nascita, nell’arte europea tra Sette e Ottocento, degli orientamenti neoclassici e puristi e del favore con cui, in urto con il Rococò, artisti e storici o teorici dell’arte, da David a Blake e Flaxman, da Winckelmann a Wackenroder, a Rio e Rumohr, avviano una stagione di radicale revisione di criteri e «valori» estetici rigettando pompa, frivolezza, malizia, sensualità, ecc. Nell’ultima parte Gombrich passa invece a considerare una diversa forma di «primitivismo», né neoclassica né purista; e muove in avanti cronologicamente per trattare di Gauguin, Picasso, Klee e altri. Non mancano i sarcasmi: eccettuati Picasso e Klee, infatti, sì «moderni» ma radicati nella tradizione, Gombrich rimprovera a Dada, New Dada, surrealismo e Art Brut l’eccessiva propensione all’«oltraggio» e il mancato riconoscimento del problema della «forma».
La preferenza per il primitivo ha consistenti meriti metodologici. In primo luogo: Gombrich torna qui ad attaccare, come ha sempre fatto, la retorica (il mito) dell’«immediatezza» in arte, provando senza difficoltà, con la consueta ampiezza di riferimenti, come qualsiasi istanza di semplificazione o tabula rasa si nutra in realtà di modelli e tradizioni; e si accompagni a «riscoperte» di epoche e stili. La parola chiave per intendere il suo pensiero è «convenzione»: ci si può muovere da un repertorio all’altro di «convenzioni» – è così che fa un artista innovativo, maturando più o meno all’improvviso l’interesse per epoche storico-artistiche o maestri sino a quel momento poco frequentati o addirittura ignorati –; ma non si può mai fare a meno di codici o, appunto, «convenzioni».
Non esiste un’arte "primitiva". Ciascun artista, già in epoche remote, si muove all’interno di una tradizione culturale che assimila, trasforma o magari contesta
Ne viene il secondo merito del libro: il rifiuto della categoria di «primitivo», in linea con gli orientamenti più recenti sia della storia dell’arte extraoccidentale (o della World Art History) sia della paleoantropologia e dell’etnografia postmoderna. Non esiste un’arte «primitiva». Ciascun artista, già in epoche remote, si muove all’interno di una tradizione culturale che assimila, trasforma o magari contesta, ma da cui non si emancipa mai definitivamente – questa la tesi. Infine, terzo merito: Gombrich accenna a una convergenza tra storia dell’arte e storia religiosa che avrebbe forse potuto condurre a ricerche ulteriori – non lo sappiamo – ma che certo si inserisce nell’attuale ambito di studi sull’uso religioso delle immagini e le implicazioni di lungo periodo della controversia che oppone iconoclasti e iconoduli all’inizio dell’epoca moderna.
Passiamo alle perplessità destate dalla lettura del testo. Colpiscono le ambizioni enciclopediche della storia o «genealogia» narrata. Gombrich segnala, nel sottotitolo, di volersi confrontare con «episodi» tratti «dalla storia del gusto e dell’arte occidentale», senza pretese di esaustività. Traccia però una storia dell’arte «primitivistica» (dalle sue origini classico-romantiche a oggi) che procede ininterrotta e sembra accampare propositi di onniscienza. Tutto questo può funzionare sotto profili retorici, e non c’è dubbio che un’esposizione tanto serrata consolidi la fama dello studioso «universale». Ma come giustificare gli omissis più vistosi, e non dichiarati? Esemplifico. Nell’introdurre il primitivismo fin de siècle, Gombrich osserva giustamente che esso sarebbe per noi incomprensibile se non facessimo riferimento alla caricatura. Tanto Gauguin quanto Picasso, ricorda Gombrich, sono abili caricaturisti. Usano la distorsione per «costruire» forme complesse e instabili, che oscillano tra tragedia e farsa. Nel far ciò, traggono spunti e modelli compositivi da tradizioni «primitivistiche», guardando l’uno – Gauguin – all’archeologia cristiana prima, all’arte polinesiana poi; all’arte africana l’altro. Verissimo. Ma l’inversione tra sublime e grottesco, così tipica dell’arte «decadente», o, detto in altri termini, l’invenzione di «mostri» simbolisti, «sintetisti», fauves o cubisti rimarrebbe inesplicabile se non considerassimo il contributo portato, sotto profili di storia e teoria della caricatura, da scrittori come Baudelaire, Champfleury e Huysmans, che Gombrich neppure nomina. Forse perché non sono essi stessi artisti figurativi, storici dell’arte o accademici? La storia della critica, viene da dire, non è una disciplina separata, quantomeno non nella misura in cui ce la rappresenta Gombrich, fedele allievo, in questo, di Schlosser. Esiste anzi per lo più in forma derivata, e i contesti, che in Gombrich sono spesso appena accennati, risultano spesso più decisivi di presunte eredità o passaggi intradisciplinari. Qui troviamo una saga: che ne è dei più modesti «episodi»?
Gombrich insiste molto, rifacendosi all’epistemologia popperiana, sulla «logica delle situazioni» per spiegare i mutamenti del gusto. Stabilita cioè una premessa, ne verrebbero pressoché inevitabilmente, e per vie interne, determinate conseguenze. Il movimento Dada o Duchamp, ad esempio, discenderebbero come per necessità, mediazione dopo mediazione, dalla «regressione» classico-romantica; e l’«originalità» delle avanguardie storiche si rivelerebbe come nient’altro che un mito. Non intendo contestare questa conclusione di Gombrich, al contrario, ma temo che parlare di «logica della situazione» possa sembrare eccessivo: una simile «logica» esiste senz’altro a posteriori, possiamo cioè rintracciarla retrospettivamente, ma nessuna innovazione si produce in maniera fatale, per così dire, e il ruolo dell’individualità creativa, o se si preferisce di un determinato contesto, è decisivo. Siamo davvero «alla ricerca di una storia culturale», come si intitola un mirabile saggio gombrichiano del 1969? Ebbene, dovremmo allora guardare al passato come a un aggregato di «costellazioni» solo in parte relate l’una all’altra o «traducibili» l’una nell’altra; e diffidare del modello narrativo offerto da una storia della scoperta scientifica di stampo lineare-evolutivo. Non è del tutto convincente neppure l’ampia digressione dedicata a illustratori ottocenteschi come Töppfer e Grandville (più specificamente «psicologica», considerati i riferimenti a Freud e al collega e amico Ernst Kris): perché, avvincente com’è se considerata da punti di vista interni, per di più opportuna per la connessione che essa stabilisce con la «cultura popolare», appare invece di incerta pertinenza se considerata nel contesto del saggio. Non è chiaro in che modo i processi di «regressione» semi-onirica (posti da Gombrich all’origine delle buffe creature o degli assemblaggi animati dei disegnatori da lui prediletti) si inseriscano stilisticamente nella storia del primitivismo, sprovvisti come sono di un qualsiasi riferimento all’arte cristiana delle origini o all’arte extraoccidentale.
È lecito ricondurre tutta la storia dell’arte del primo Novecento, o gran parte di essa, sotto la categoria della "provocazione"?
È lecito ricondurre tutta la storia dell’arte del primo Novecento, o gran parte di essa, sotto la categoria della «provocazione», negando di fatto che artisti come Kandinsky, o Marc, o Duchamp appunto si siano posti problemi di «forma»? La migliore filologia, in questi ultimi decenni, sembra provare il contrario. Anziché postulare, quanto a avanguardie storiche e neoavanguardie, che tutto, o molto, si riduca a malizia e cinismo, sarebbe risultato più rispettoso della complessità storica avvicinare questo o quel case study per comprendere perché e come, a una certa data, diciamo 1910, o forse prima, il distacco dalla tradizione «mimetica» diventi pressoché imperativo e da più parti si avverta l’esigenza di creare «geroglifiche contemporanee» – cito qui Marc. La diffusione di gallerie private, a Parigi e in Germania, e la competizione commerciale internazionale possono avere spinto taluni al conformismo. Va bene. Ma la sola sociologia culturale non spiega mutamenti tanto radicali.
Gombrich concede volentieri, lo si è già ricordato, che nessun artista sia «primitivo». Tuttavia rigetta ogni relativismo e tiene per fermo il primato dell’arte classico-rinascimentale. Che si dia mimesis, afferma, non è ovvio né scontato. È anzi sorprendente che in Occidente si sia affermata una tradizione capace di «imitare» le apparenze naturali, perché la grande maggioranza delle tradizioni storico-artistiche pre-classiche o extraoccidentali prediligono invece rappresentazioni schematiche. Ciascun artista, dal punto di vista di Gombrich, ha la sua tradizione, quali che siano l’epoca e il luogo. Non tutte le tradizioni hanno però uguale complessità tecnica, né recano con sé il vantaggio di una maturità linguistico-cognitiva tanto spiccata. Studiare il mondo come appare, interrogare i fenomeni e infine riprodurli con abilità richiede tempo e impegno: e, fatte salve poche e sporadiche eccezioni extra-occidentali – come l’arte di corte del Benin, ad esempio – l’arte europea è stata per lungo tempo la sola capace di affrontare e risolvere le difficoltà inerenti alla rappresentazione «mimetica» o naturalistica. Questa sua prerogativa risulta oggi negata in nome di questa o quella tentazione «primitivistica». Tale «tradimento dei chierici», per Gombrich – che proprio qui rivela l’invalicabile distanza che lo separa dal Warburg «etnografo» –, equivale non solo né tanto a una «crisi di civiltà», oggi come all’indomani della Prima Guerra mondiale; ma soprattutto a una capitolazione agli irrazionalismi più funesti, estetici e non solo.

Riproduzione riservata