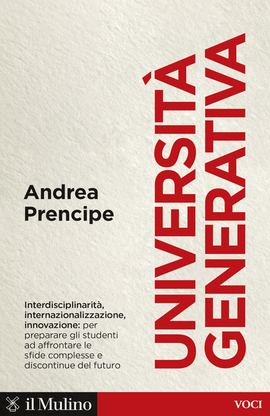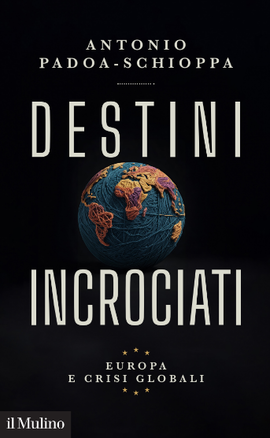La frontiera di Alessandro Leogrande (Feltrinelli, 2015) è un libro necessario. Ne sentivo il bisogno. Tuttavia, mi ha lasciato l’amaro in bocca, perché non spinge fino in fondo le proprie riflessioni, non spiega completamente cos’è e come funziona la frontiera. È un libro necessario per molte ragioni. Dopo il naufragio avvenuto a pochi metri da Lampedusa il 3 ottobre 2013 in cui morirono almeno 366 persone, quasi tutti eritrei, era necessario che qualcuno raccontasse quella vicenda e ne analizzasse le cause, le responsabilità.
La morte di decine di migliaia di migranti nel Mediterraneo e alle altre frontiere dell’Unione è una delle questioni più drammatiche degli ultimi quindici anni per l’Europa. Il blog Fortress Europe ha documentato 27.300 morti a partire dal 1988, 3.500 nel 2014, 4.270 nel 2015. E prima ci sono il Sahara e le carceri libiche. Una tragedia di dimensioni enormi, della quale riceviamo notizie quotidianamente sui telegiornali, rispetto alla quale siamo passivi, perché è quasi impossibile trovare delle modalità di intervento incisive.
Leogrande ha deciso di occuparsi di questa tragedia. Racconta le storie di alcuni dei deceduti a Lampedusa, dei loro parenti in Europa, dei sopravvissuti. Riporta le terribili esperienze dei viaggi dall’Eritrea all’Europa. I ricatti, le prigioni, le torture, gli omicidi. Cerca di capire se e come sia possibile elaborare un lutto così grande. Nel libro ci sono poi altre frontiere, altre migrazioni, altre sofferenze, dal Kurdistan e dall’Afghanistan.
La frontiera è un libro necessario perché prova a spiegare le motivazioni che spingono centinaia di migliaia di persone a partire. In particolare, approfondisce la storia della dittatura spietata di Isaias Afewerki in Eritrea. Non si potranno mai bloccare i viaggi, è la conclusione di Leogrande: “se continuano a scappare in massa, è perché stanno fuggendo da una violenza ancora più efferata. Dalla certezza della morte, o da quella di una vita non vissuta”.
Inoltre, Leogrande ricorda le responsabilità storiche dell’Italia rispetto alla situazione in Eritrea, che risalgono al dominio coloniale su quel territorio, così come sulla Somalia, l’Etiopia, la Libia. “Sono le nostre ex colonie uno dei principali ventri aperti dell’Africa contemporanea. I luoghi di partenza di molti viaggi della speranza sono stati un tempo cantati ed esaltati come suolo italiano, sulle cui zolle far sorgere l’alba di un nuovo impero”. Un passato molto concreto, se non altro perché “alcuni dei campi di concentramento eretti negli ultimi anni da Isaias Afewerki per reprimere gli oppositori sorgono negli stessi luoghi dove erano disposti i vecchi campi di concentramento del colonialismo italiano”.
Raccontare e analizzare tutto questo era necessario. Tuttavia, mi pare che nel libro venga dedicato uno spazio molto minore a un’analisi delle scelte e delle responsabilità italiane ed europee nella costruzione della frontiera. Leogrande smonta giustamente le posizioni di quanti chiedono un blocco navale che fermi i viaggi; ricorda quanto siano inumani e inutili i centri di identificazione ed espulsione. Ma non mette al centro un aspetto a mio parere fondamentale: i morti in mare sono dovuti non tanto a guerre e dittature che causano la fuga, ma anche e soprattutto al fatto che ai migranti in fuga non è concesso entrare in Europa, se non rischiando la vita nel deserto e nel mare.
Un cittadino europeo che voglia viaggiare in quasi tutti i Paesi del mondo non ha che da chiedere un visto e, in poco tempo, lo otterrà. Lo stesso non è concesso ai cittadini della gran parte degli Stati non europei. Non solo a quanti vogliono fuggire da situazioni di povertà (e si dovrebbe ragionare sulle cause di questa povertà e sulle responsabilità dei Paesi sviluppati). Ma neanche a coloro che fuggono da guerre e dittature. Un eritreo e un siriano sanno che la loro domanda di protezione internazionale in Europa quasi sicuramente verrà accettata. Ma non è permesso loro, una volta usciti dal loro Paese, di prendere un volo e arrivare in sicurezza in un aeroporto europeo. Le politiche europee li costringono, per presentare domanda di protezione, a rischiare la vita. E spesso a morire.
Leogrande afferma che “l’unica cosa da fare nell’immediato per arginare le morti in mare è ripristinare qualcosa di molto simile a Mare Nostrum, con il coinvolgimento delle risorse e delle unità navali degli altri Paesi europei”. Mare Nostrum ha salvato centinaia di migliaia di migranti, viene ricordato. Certo, ma i migranti prendono il mare pagando i passeurs perché non possono utilizzare altri mezzi di trasporto per arrivare in Europa. Questo l’ha deciso l’Europa, non Afewerki o Assad. A me pare paradossale salvare i migranti dal mare (e ammantarsi di solidarietà per questo) dopo che non si è consentito loro di utilizzare mezzi di trasporto più sicuri.
Per evitare le stragi dei migranti nel Mediterraneo e nel Sahara, bisognerebbe invece, forse, consentire loro di entrare in Europa autonomamente, dai Paesi d’origine o, quando questo non sia possibile, da un Paese vicino. Qualcuno – non certo Leogrande – risponderà istintivamente: è impossibile, ci sarebbe l’invasione, verrebbero tutti qui. In realtà, questo non è scontato; anzi, in altri casi di “apertura della frontiera” (vedi l’allargamento a Est dell’ Unione europea) non è successo. Ma il punto non è questo. Aprire o chiudere una frontiera è una scelta politica. Per il diritto internazionale è legittimo che l’Europa decida per la chiusura, ma è precisamente questa scelta che la rende corresponsabile della morte e delle sofferenze di tanti migranti.
Leogrande si chiede “come maneggiare la memoria e il dolore” di tante stragi e “come evitare di essere parte di un enorme processo di spettacolarizzazione”. Forse la risposta non sta solo nello stile del racconto, ma anche nel tentativo di mettere radicalmente in discussione le scelte politiche che di quelle stragi sono una delle cause.

Riproduzione riservata