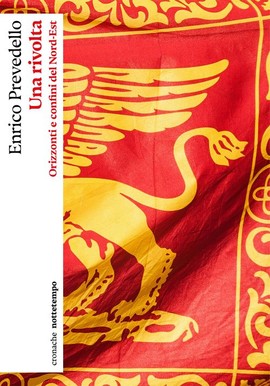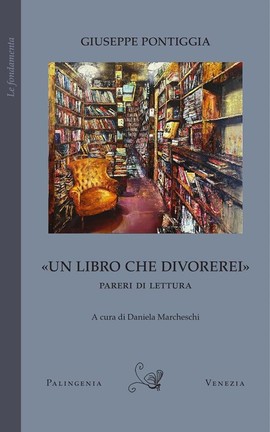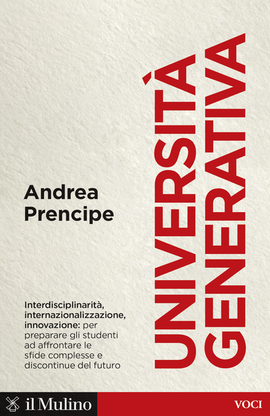Il più delle volte, le discipline politiche più diffuse tendono a essere piuttosto noiose. Seguendo l’esempio di dipartimenti e riviste americane, la ricerca su temi di reale interesse intrinseco sembra arenarsi in tentativi interminabili di modulare le opzioni tra l’office-seeking – l’orientamento a governare – e il policy-seeking – quello di rappresentare politicamente; l’interazione tra i partiti che puntano a massimizzare il risultato elettorale e gli elettori “strategici”;l’organizzazione delle preferenze degli elettori o le dinamiche di formazioni delle coalizioni; il tutto nel quadro di principi generali senza tempo, destinati a rappresentarsi tramite sistemi complessi di equazioni formali.
Esistono tuttavia le eccezioni. Tra queste, una delle più notevoli era rappresentata, fino alla sua prematura scomparsa nell'estate del 2011, da Peter Mair, docente di Politica comparata all'Istituto universitario europeo di Firenze. Largamente stimato, soprattutto dal versante europeo della sua professione, Mair ha conservato una profonda comprensione sia della storia sia dell’obiettivo degli studi sulla democrazia. A differenza di molti nel settore, non ha mai perso di vista la stretta relazione tra i partiti politici di massa e i loro esiti in termini di democrazia; il suo lavoro ha sempre considerato lo sviluppo dei primi saldamente nel contesto di quest'ultima, come la più importante tra i due. Inoltre, la sua preoccupazione era spudoratamente a favore della democrazia popolare e dell’emancipazione della gente comune, piuttosto che per le regole astratte del processo decisionale, oggi diventate il soggetto preferito di gran parte di ciò che passa per teoria democratica.
Ruling the Void è il più recente, e purtroppo anche l’ultimo, libro di Mair. Completa un’opera iniziata con The Changing Irish Party System (Frances Pinter, 1987), uno studio tuttora insuperato sul suo Paese natale, proseguita con la pietra miliare Identity, Competition and Electoral Availability (Cambridge University Press, 1990, scritto con Stefano Bartolini), che si concentrava sulla sorprendente stabilità nel lungo periodo del sistema partitico occidentale, sebbene erosa da una crescente volatilità elettorale a partire dagli anni Settanta. A questo seguì il pregevole Party System Change (The Clarendon Press, 1997), e una serie di pubblicazioni in collaborazione con altri. Ruling the Void era ancora incompleto alla sua scomparsa, ma gli argomenti principali erano già stati predisposti. È merito di Francis Mulhern, suo amico dai tempi dell’università, l’aver organizzato quel che c’era in una sequenza estremamente leggibile e coerente, attingendo ulteriore materiale per comporre il lungo capitolo sull’Unione europea che chiude il libro. Lo stile incisivo di Mair, in particolare la sua capacità di trovare espressioni chiare e affilate per ciò che aveva da dire, è evidente fin dalle prime righe:
“L'età della democrazia dei partiti è finita. Sebbene i partiti stessi continuino a esistere, sono diventati così scollegati dalla società nel suo insieme, e perseguono una forma di competizione così priva di significato che non appaiono più in grado di sostenere la democrazia nella sua forma attuale.”
Nel prosieguo, Mair elabora questa premessa con il sostegno di una mole di dati impressionante, mentre illustra questo declino sia dal basso – con il calo di affluenza alle urne e di appartenenza ai partiti – sia dall’alto – con il “ritiro delle élite” dalla responsabilità democratica. Non possiamo sapere come si sarebbe presentato Ruling the Void se Mair avesse avuto il tempo di finirlo, ma possiamo star certi che le linee portanti sarebbero state le stesse, come non ultimo il fermo rifiuto dell’autore a ritrarsi dalle grandi questioni a favore della purezza metodologica. Colpisce particolarmente il fatto che Mair apprezzava profondamente i partiti quali agenzie intermediarie tra i loro elettori e le istituzioni politiche dello Stato, due ambiti connotati da dinamiche e contingenze strategiche molto diverse. Si annovera tra i grandi risultati di Mair come scienziato politico il fatto che abbia resistito a specializzarsi nell’uno o nell’altro ambito, sebbene entrambi richiedano la padronanza di conoscenze e metodi di ricerca altamente specializzati. Secondo Mair, proprio la mediazione operata dai partiti politici tra questi due campi di azione definiva il loro ruolo; ciò che lo interessava di più era il modo in cui le loro reazioni venivano determinate e combinate in entrambe le zone.
Qual è dunque il messaggio di questo libro importante? Mair va oltre il formato standard della politica comparata e guarda meno alle differenze nazionali tra i sistemi partitici che ai punti in comune e alle traiettorie storiche condivise. Delinea brevemente l’“età dell’oro” della democrazia rappresentativa. Con l’avvento del suffragio universale verso l’inizio del Novecento, i primi “partiti dei notabili” furono soppiantati da organizzazioni di massa dotate di strutture forti e gerarchiche, che raggruppavano gli elettori sulla base di esperienze sociali comuni e delle speranze collettive verso ciò che il partito avrebbe ottenuto una volta al governo. Il ruolo del partito era di tradurre gli interessi dei suoi elettori in politiche pubbliche, reclutare e formare leader politici capaci di esercitare il potere esecutivo e competere per il controllo del governo attraverso elezioni nazionali. Il classico partito di massa, scrive Mair, “dava voce al popolo”, e al tempo stesso creava la garanzia della responsabilità delle istituzioni di governo. Mair descrive l’evoluzione dei partiti tradizionali a partire dalla metà degli anni Sessanta verso ciò che lo scienziato politico socialdemocratico Otto Kirchheimer descrisse come “modello pigliatutto”: partiti che, con l’obiettivo di raccogliere voti molto al di fuori delle proprie appartenenze fondamentali, diventano “principalmente office-seeking, mossi dal desiderio di assicurarsi la vittoria e occupare posti di governo molto più che da ogni senso di integrità rappresentativa. Lo stadio successivo, che si condensa tra la metà degli anni Ottanta e Novanta, è quello che Mair e Richard Katz, di nuovo seguendo Kirchheimer, hanno chiamato “il governo dei cartelli”, caratterizzato dall’eliminazione di ogni effettiva opposizione, che è la situazione che si verifica quando “nessuna differenza significativa caratterizza i partiti protagonisti, per quanto vigorosamente possano di volta in volta competere l’uno con l’altro”.
Gli ultimi decenni del XX secolo mostrano dunque un “ritiro graduale ma inesorabile dei partiti dall’ambito della società civile verso l’ambito del governo e dello Stato”. Come sottolinea Mair, questo “ritiro delle élite” è stato accompagnato dal parallelo disimpegno dei cittadini, che di decennio in decennio cala costantemente, insieme all’affluenza media e al venir meno del coinvolgimento popolare nella vita politica. Questo processo comprende la contrazione del ruolo del “partito sul territorio”, a favore del “partito in parlamento”, o al governo, da quando i leader – per usare un altro memorabile dittico di Mair – hanno optato per la “responsabilità” a spese della “reattività”. E mentre i partiti si sono ritirati sempre più lontano dai propri elettori, si sono avvicinati gli uni agli altri: “Quello che rimane è una classe dirigente”.
Mair evita attentamente le narrazioni monocausali, o perlomeno il ragionamento monodirezionale rispetto alle cause. Egli attribuisce l’esautorazione del governo partitico democratico alla somma dei mutamenti di limiti e opportunità incontrati dai partiti nelle sfere tra le quali tradizionalmente erano dei mediatori: da un lato le loro basi sociali, e dall’altro le matrici dei payoff dell’arena politica. Tali cambiamenti riguardano due tendenze generali, l’una verso l’individualizzazione, l’altra verso la globalizzazione. La prima riguarda l’erosione del contesto sociale coesivo che aiutò a strutturare la crescita originaria dei partiti di massa – il mondo dei sindacati, associazioni, chiese, associazioni di categoria, gruppi agricoli e così via – così come la frammentazione delle identità collettive, inclusa quella della classe operaia industriale. Si invoca l’individualizzazione nelle sue diverse espressioni per spiegare la crescente indifferenza e apatia mostrate dai cittadini per gli interessi comuni e la politica, che configurano una disintegrazione secolare del “demos” contemporaneo. Dal canto suo la globalizzazione incide sul venir meno della capacità dei governi nazionali a tracciare politiche autonome. Queste due tendenze producono effetti simili sul governo partitico. “Sia che siano costretti da vincoli globali o europei, o che siano limitati dalla loro incapacità a identificare una base elettorale abbastanza ampia e coesa da offrire loro un mandato ad agire – scrive Mair – i partiti tendono sempre di più ad echeggiarsi l’un l’altro e a sfocare quelle che apparirebbero altrimenti chiare scelte politiche. Inoltre, dovendo fronteggiare una base sociale che si sgretola, le elite di partito hanno cercato rifugio nella sicurezza che le istituzioni statali offrono ai politici disposti ad accettare “un’intesa di ufficio, di programmi e di elettori”. In questo quadro, il processo decisionale politico si è spostato in capo a istituzioni “non maggioritarie” (ovvero élitarie), quali banche centrali e agenzie di controllo, che restano isolate dalle pressioni redistributive “maggioritarie”; pressioni per le quali i governi devono comunque lottare per dare una risposta da quando la globalizzazione ha indebolito i poteri economici degli Stati-nazione, che erano una volta le sedi della democrazia popolare.
La prova centrale di Mair a sostegno di un sistema politico gestito da una governance di esperti depoliticizzati, costruito specificatamente per escludere i partiti, la democrazia popolare, e con essi, le politiche redistributive, è naturalmente l’Unione Europea, come mostrato nel capitolo finale del libro. È a dimostrazione dell’acutezza di analisi di Mair il fatto che egli abbia compreso la logica politica-economica di questa entità molto meglio dei tanti scienziati politici specializzati nello studio – per non dire nella celebrazione – dell’“integrazione europea”, per i quali il maggior successo risiede nella scoperta del “deficit democratico” di un sistema politico nel quale difendere il processo decisionale collettivo dalla democrazia non era nientemeno che il principio fondamentale. L’ultimo capitolo non lascia alcuna illusione rispetto alla possibilità, instancabilmente evocata dalla retorica sulla “democratizzazione” delle forze a favore di una “maggiore Europa”, di attribuire all’Ue il ruolo di base della resistenza contro gli effetti debilitanti dell’internazionalizzazione capitalista. Come puntualizza Mair, facendo riferimento alle riflessioni di Robert Dahl sull’opposizione: “siamo stati forniti del diritto di essere rappresentati in Europa, sebbene a volte sia difficile capire quando e come tale legame rappresentativo funzioni; ma non siamo stati forniti del diritto di organizzare una opposizione nella comunità politica europea”:
“Sappiamo che un fallimento del consenso all’ingresso dell’opposizione nel sistema politico è suscettibile di portare o a) all’eliminazione di ogni significativa opposizione e a una sottomissione più o meno totale, o b) alla mobilitazione di un’opposizione di principio contro il sistema politico, ossia all’opposizione anti-europea e all’euroscetticismo. E, in effetti, un simile sviluppo si sta producendo giù nella sfera domestica, dove il peso crescente dell’Ue e il suo impatto indiretto sulla politica nazionale, contribuisce a scavare il deficit democratico e pertanto limita il raggio d’azione dell’opposizione tradizionale a livello nazionale.”
Mair conclude con una lucida riflessione: perdendo l’opposizione noi perdiamo la voce, e perdendo la voce perdiamo il controllo dei nostri sistemi politici; non è affatto chiaro in che modo tale controllo possa essere recuperato, scrive, facendo riferimento al ripristino dell’opposizione, la pietra miliare della democrazia.
Ruling the Void è una lettura fondamentale per chiunque si occupi di politica nel XXI secolo. Per quanto sia stringente, il libro resta ambiguo su una serie di questioni intriganti. La prima è perché a partire dagli anni Ottanta i partiti politici tradizionali in Occidente abbiano reciso i legami con la loro base sociale e abbiano adottato il pensiero unico neoliberista. È stato perché le mutate condizioni oggettive non lasciavano loro altra scelta? Era opportunismo organizzativo, la seduzione della condivisione del potere tecnocratico? O perché la loro base elettorale li aveva disertati e non era più disponibile per la mobilitazione collettiva? A un certo punto, Mair afferma in modo inequivocabile che il ritiro è stato reciproco “questa è la conclusione che occorre sottolineare nel modo più chiaro”; ma non entra a esplorare la natura specifica di questa reciprocità. Non discute neanche la questione generale della possibile relazione di causa-effetto tra le due tendenze, o la direzione verso la quale essa si possa muovere; se ognuno dei ritiri sia dipeso dall’altro e in che misura essi si siano rafforzati a vicenda.
È qui in particolare che viene il desiderio che Mair avesse avuto il tempo per rispondere a una serie di domande che avrebbero potuto spingere più in profondità la sua analisi. Una riguarda il suo concetto chiave di globalizzazione e ciò che essa rappresenta. È ampiamente noto come la crescente internazionalizzazione dell’economia capitalista a partire dagli anni Ottanta abbia reso sempre più difficile per i governi nazionali intervenire in favore delle maggioranze popolari. Tuttavia le pressioni per la protezione dell’accumulazione di capitale contro le interferenze democratiche sono antecedenti e suggeriscono una tensione più profonda tra il capitalismo e la democrazia, che è stata solo provvisoriamente sospesa nei pochi decenni di crescita del dopoguerra. Mantenendosi nel suo terreno della scienza politica, Mair si trattiene dall'avventurarsi nell’economia politica, sebbene le tendenze che descrive – il trasferimento della politica economica nelle mani di istituzioni tecnocratiche “non responsabili”; l’eliminazione della redistribuzione egalitaria dall’agenda politica dei governi occidentali – suggerisca la nascita di un nuovo regime politico-economico, dopo che il capitale ha vinto le lotte degli anni Settanta.
La storia di Mair sull’esautorazione della democrazia di massa si adatterebbe bene a un più generale resoconto di come il regime di crescita keynesiano postbellico – costretto a cercare il progresso economico tramite la redistribuzione dall’alto al basso – si sia trasformato in un regime hayekiano, che punta le sue speranze nella redistribuzione dal basso verso l’alto. Potrebbe anche più genericamente, collocarsi nel quadro del dilemma basilare della politica democratica nel capitalismo: la democrazia egualitaria ha facoltà, in periodi favorevoli, di aiutare a gestire le tensioni sociali prodotte dalla natura del processo di accumulazione capitalistica; tuttavia, nel corso del processo essa può anche provocare turbolenze economiche, fughe di capitali e così via, dinamiche che minano i presupposti di un governo di successo. In situazioni simili, i partiti di governo possono pensare di non avere altra scelta che di diventare “responsabili” e di allearsi con la classe capitalista, al contempo proteggendosi come meglio possono dalle pressioni di “rispondere” ai loro membri ed elettori.
Un’altra questione è se i partiti politici principali oggi saprebbero effettivamente sostenere la possibilità di organizzare e mobilitare i propri elettori nelle modalità che negli anni Settanta erano date per scontato. Mair sottolinea l’individualizzazione e la frammentazione delle loro basi sociali, che è diventata un fenomeno generale a partire dagli anni Novanta, e che ha indebolito in particolare i partiti di sinistra. Ma questo potrebbe essere solo la superficie di un mutamento più profondo nel modo in cui le persone si relazionano a vicenda, ovvero nella natura stessa della socialità e della struttura sociale – un mutamento che stiamo solo cominciando a comprendere dopo la svolta dei cosiddetti social-media. L’individualizzazione, come sostengono Mair e altri, sembra essere nient’altro che un concetto provvisorio per descrivere la crescente tendenza al breve termine e alla volatilità rispetto agli impegni sociali in generale, non solo per quanto riguarda la vita civica e politica ma anche per quella privata e familiare, e certamente per il lavoro e i beni di consumo; una tendenza che molti interpretano come un guadagno in libertà piuttosto che una perdita in solidarietà. Cosa questo faccia presagire per la politica potrebbe forse comprendere l’opzione “voce” nel senso di Albert Hirschman, ma soprattutto l’opzione “uscita”, spesso e volentieri, e molto poco l’opzione “lealtà”, quando si arriva al compromesso e alla disciplina al servizio di valori condivisi necessari per una visione collettiva della buona società.
In quello che sembra l’ordine emergente, i legami sociali sono intesi come una questione di gusto e di scelta piuttosto che di obbligo, facendo apparire le comunità come associazioni di volontariato dalla quali ci si può dimettere qualora richiedessero eccessiva abnegazione, piuttosto che come “comunità di destino” con le quali o sopravvivere o affondare. I nuovi mezzi social di comunicazione, che sono diventati strumenti quasi indispensabili dell’umana socialità, consentono alle persone di collegarsi e associarsi con altri simili a sé rispetto alle questioni “soggettive” le più esoteriche. Mentre il cyberspazio spazza via la geografia, viene spezzato il collegamento, fondamentale per la mobilitazione politica tradizionale, tra interessi condivisi e relazioni personali derivanti dalla prossimità fisica. Una conseguenza è che il controllo sociale tra i “membri della rete” è ridotto al minimo, e uscirne è molto facile, soprattutto quando si usano degli pseudonimi: un altro volto del nuovo volontarismo delle relazioni sociali. Navigando nella sterminata offerta di cause, gusti e stili di vita resi disponibili da internet, si può liberamente decidere di mettere un “like” a tutto ciò che si vuole; in contrasto con la vecchia scuola dei partiti politici, non è richiesta alcuna coerenza ideologica né l’adesione a un programma comune.
È difficile ignorare l’analogia presente tra la modalità consumistica che ha pervaso l’impegno politico e i nuovi mercati capitalisti di stile di vita edonistici, alimentati da prodotti personalizzati su misura dell’individuo. Così, sostenendo lo sforzo nazionale per aumentare l’affluenza alle urne alle elezioni europee del maggio 2014, la "Frankfurter Allgemeine" aveva offerto ai suoi lettori un quiz online – costruito, per inciso, dall’Istituto universitario europeo di Firenze – con il titolo Quale partito si adatta meglio a me?, piuttosto che, come ci si potrebbe ingenuamente aspettare, Quale partito si adatta meglio all’Europa?. Nel frattempo, tutte le questioni cruciali della politica europea erano state accuratamente accantonate dalle due vecchie mani di Bruxelles che si presentavano come capilista continentali per la presidenza della Commissione europea. Fingendo di essere in competizione, correvano su piattaforme praticamente identiche. Non si può trovare conferma migliore delle tesi di Mair circa il “cartello di governo” e della sua brillante analisi della politica dell’Ue presentata nell’ultimo capitolo di Ruling the Void.
Come già detto, Mair presenta due spiegazioni riguardo alla sua scoperta che i partiti politici si sono ritirati dalla loro posizione di mediazione tra i loro elettori e lo Stato. Una è che le oggettive circostanze politiche economiche hanno loro reso impossibile restare sensibili alle esigenze e alle richieste popolari, vincolandoli a politiche inadatte a sollecitare l’impegno politico e civile. In secondo luogo, egli suggerisce che non è più possibile ricondurre la loro base sociale a portare avanti il tipo di azione collettiva che i partiti tradizionalmente ispiravano. (Se nel XIX secolo era il Lumpenproletariato a essere incapace di organizzazione disciplinata, oggi potrebbe essere la classe media edonistica. Un esempio delle misure disperate a cui stanno ricorrendo i partiti istituzionali per arrestare l’emorragia delle loro appartenenze è offerta dalla sezione giovanile della Cdu tedesca: aveva lanciato una campagna di tesseramento promuovendo il colore del partito, il nero – dotato di significato originariamente clericale, derivante dalla talare nera dei preti cattolici – con lo slogan “Black is beautiful”, ovviamente in inglese. Gli attivisti avevano organizzato delle feste nelle quali, tra le altre cose, distribuivano preservativi neri.)
Quello che Mair però non riesce a spiegare è se queste due tendenze – macro e micro – siano in qualche modo collegate. Si potrebbero prendere in considerazione molti collegamenti, a partire dalla globalizzazione dei sistemi di produzione e dei mercati del lavoro, che hanno eroso le strutture di classe delle società capitaliste avanzate, fino all’avvento del capitalismo di consumo con la sua individualizzazione commerciale e la privatizzazione della soddisfazione del bisogno. L’inquietante conclusione potrebbe essere che nel capitalismo odierno, la legittimità del sistema derivi dal consumo individuale su mercati che non sono limitati da confini giurisdizionali, piuttosto che dalla correzione politica dei mercati nel quadro di Stati nazionali o dalla deliberazione democratica su interessi collettivi operata in comunità politiche. Dal momento che la scelta del consumatore individuale prende il posto della scelta politica, l’intermediazione degli interessi operata dalle organizzazioni politiche può essere percepita come superflua, o peggio, limitante. Lo sviluppo capitalistico potrebbe essere arrivato in misura notevole, oggi più che mai, a consistere in una socializzazione di mercato che travolge e sostituisce la comunitarizzazione politica.
Il resoconto di Mair si concentra principalmente sull’Europa occidentale e sulle nuove democrazie dell’Est, a discapito degli Stati Uniti. Laddove la tendenza si presenta opposta: una crescente polarizzazione tra i partiti politici principali, una calante propensione al compromesso che produce un blocco generale del governo, un ritorno alla “risposta” contro la “responsabilità”, con la politica che trionfa sulla ricerca dell’incarico di governo: tutto ciò in contraddizione col modello stabilito della predominanza dell’elettore mediano, come sottolineano in un recente saggio Jacob Hacker e Paul Pierson, autori di Winner-Takes-All Politics; tanto più che le preferenze degli elettori negli Stati Uniti appaiono essere rimaste sostanzialmente invariate. La rinascita della purezza ideologica negli Stati Uniti ha avuto luogo principalmente a destra, nel Partito Repubblicano, mentre i democratici sono di fatto rimasti in una posizione centrista, cosa che approfondisce ulteriormente il divario tra i due partiti – donde il termine “polarizzazione asimmetrica”. Ma perché un partito dovrebbe di fatto privarsi della possibilità di costruire una maggioranza nazionale, per lo scopo di rappresentare più autenticamente un ristretto nucleo di elettori? È qui che entrano in gioco i gruppi di interesse, specialmente quelli del capitale, un soggetto che Mair tocca soltanto marginalmente. Nel saggio di Hacker e Pierson, la lobby degli affari statunitense opera come una specie di equivalente funzionale dello Stato europeo, fornendo il supporto finanziario al suo partito preferito, liberandolo dalla schiavitù dell’elettore mediano. In un sistema politico di governo diviso, il partito può così dedicarsi a bloccare la legislazione, preservando in tal modo lo status quo istituzionale in un mondo di rapidi mutamenti sociali ed economici. Il risultato è ciò che Hacker altrove chiama “deriva” politica: il progressivo indebolimento delle politiche e delle istituzioni redistributive, ottenuto negando loro l’aggiornamento regolare di cui abbisognano per tenere il passo con l’ambiente che cambia. Neutralizzare lo Stato in questo modo può essere apparentemente un efficace equivalente politico della “globalizzazione”, in un Paese che in linea di principio sarebbe ancora abbastanza egemone per guidare alternative realistiche al neoliberalismo.
È ironico che la ri-politicizzazione odierna appaia principalmente confinata a destra, e non solo negli Stati Uniti: basti considerare i nuovi partiti “populisti” in Europa che godono in gran parte dell’abbandono della vecchia base elettorale del centro-sinistra, e che vanno perseguendo grandi coalizioni con il centro-destra. Per quanto riguarda gli interessi organizzati, vale la pena notare che nel momento stesso in cui i partiti “pigliatutto” e le loro élite sono impegnati nella corsa al ritiro dalla loro base sociale, le associazioni di affari in Europa sono diventate più attente alla propria “logica di appartenenza”, liberandosi da coinvolgimenti corporativi con i sindacati e con lo Stato e radicalizzando la propria retorica come pure la propria posizione politica. Tali dinamiche non faranno che intensificare gli sviluppi così finemente previsti da Ruling the Void.
[A questa recensione di Streeck, originariamente pubblicata sulla “New Left Review”, 88, July-August 2014, pp. 121-129 e tradotta in italiano da Lucia Bruni, fa riferimento Maurizio Ferrera in Partiti, rappresentanza, Europa, sul numero del "Mulino" in uscita, 2/15, pp. 383-391]

Riproduzione riservata