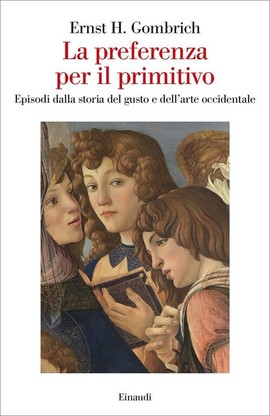Un «rumore sordo, un rumore indescrivibile». È così che Marco Prato racconta agli inquirenti cosa ha sentito nel momento in cui lui e Manuel Foffo hanno ucciso Luca Varani. Stando a quanto raccontano le cronache, invece, gli inquilini degli appartamenti vicini non si sarebbero accorti di nulla. Non hanno sentito niente, nemmeno un grido.
Un rumore, quindi, non così facile da percepire se non tendi l’orecchio per bene, se non fai attenzione. Un rumore silenzioso, un ossimoro. Un’opposizione tra le tante che l’ultimo romanzo di Nicola Lagioia, La città dei vivi (Einaudi, 2020), cerca di mettere in luce, scavando nell’interiorità dei personaggi, conseguentemente nella nostra, e portando a galla le contraddizioni che abitano le nostre esistenze. L’essere e l’apparire, l’abisso e la superficie, l’io pubblico e l’io privato.
La narrazione prende spunto da un caso di cronaca nera, avvenuto ai primi di marzo del 2016. Siamo a Roma, la città «caotica», «vitale», «tremendamente cinica». La primavera agli esordi, anche se il cielo di quei giorni era grigio. Una metafora, forse. La Roma dei turisti, del centro e delle periferie, delle fontane con l’acqua che scorre e lava la pietra. Un’altra metafora. Un ragazzo di ventitré anni viene invitato a prendere parte a un festino privato nell’appartamento di uno dei due assassini, in via Igino Giordani, nella parte est della città. La droga, il sesso e lo sballo fanno da sottofondo a questa «storia sbagliata» che porta prima allo stordimento di Luca e poi alla sua morte, inferta con oltre un centinaio di colpi tra ferite da coltello e martellate. Il caso, nei giorni successivi, riempirà le pagine dei quotidiani nazionali e richiamerà l’attenzione dei media tra chi ne parlerà per professione, chi per curiosità e chi per sconcerto. Il racconto di Lagioia ripercorre i mesi prima del delitto, cuce insieme i diversi punti di vista, affianca i protagonisti nelle parole, nei gesti con cui premeditano l’omicidio e non li abbandona neanche dopo il loro arresto. Una storia del genere è una storia che non lascia indifferenti. Da un punto di vista sociale, riporta alla memoria il racconto pasoliniano dei ragazzi di vita, citati dallo stesso Lagioia e «confinati in una preistoria incantata». Da un punto di vista giornalistico, richiama alla mente i tanti delitti efferati di cui parlano giornali e tv. Ma quello che fa Lagioia è molto di più che scavare nei ricordi di qualche anno fa per sollevare la nostra indignazione e farci condannare senza esitazione i due colpevoli: ci offre un itinerario filosofico e antropologico, ai confini della morale. Lì dove il margine tra noi che siamo i buoni e loro che sono i cattivi si assottiglia, dove fai i conti con le esperienze della vita, con i volti, con gli attimi che ti hanno fatto prendere una direzione piuttosto che un’altra.
Immergersi ne La città dei vivi significa innanzitutto cambiare il proprio punto di vista. «Tutti temiamo di vestire i panni della vittima – scrive l’autore – Viviamo nell’incubo di venire derubati, ingannati, aggrediti, calpestati. È più difficile avere paura del contrario. Preghiamo Dio o il destino di non farci trovare per strada un assassino. Ma quale ostacolo emotivo dobbiamo superare per immaginare di poter essere noi, un giorno, a vestire i panni del carnefice?».
Che la possibilità di compiere il male e di scoprirlo dentro di noi sia più banale di quanto ci possiamo apparentemente immaginare ce lo aveva già detto Hannah Arendt, dopo aver assistito al processo ad Adolf Eichmann all’inizio degli anni Sessanta del secolo scorso. L’intento della Arendt, come in questo caso, era stato quello di scavare nel profondo dell’abisso dell’uomo, di inoltrarsi nei sentieri più bui dell’essere umano, per provare a comprendere l’incomprensibile. La riflessione della Arendt l’aveva portata ad ammettere che il male è molto più superficiale di quanto crediamo. L’individuo isolato dalla dimensione politica e sociale, l’individuo che abdica il pensiero diventa più vulnerabile e dimentica il senso della responsabilità e il rispetto per l’altro. In breve, Arendt riconosce solo nella capacità di riflessione, intesa come dialogo con sé stessi, e nell’apertura all’individuo gli antidoti al diffondersi dell’apatia. La relazione, quindi, come possibilità di arginare il male.
Ma non è ancora abbastanza. D’altronde, i protagonisti della vicenda di cui scrive Lagioia non sono ufficiali nazisti ma trentenni della piccola e media borghesia romana, con i loro giri di amicizie nella Capitale e qualche progetto per il futuro. Giovani come altri tanti giovani, eppure capaci di un gesto atroce. «Che tipo di persone erano due imputati del genere? Erano afflitti da gravi problemi psichiatrici? O erano dei “mostri”?». È questo uno degli interrogativi che attraversa la narrazione. L’etichetta più facile, certamente, e più consolatoria. Eppure è proprio il padre di Luca Varani – ci racconta l’autore – a insegnarci a non ricorrere a quella parola. «Disse che avevano fatto una cosa mostruosa, che si erano comportati come dei mostri, ma erano degli esseri umani, creature per correggere le quali non bastava l’astratta enunciazione di un principio morale».
A tal proposito, Adolfo Ceretti (tra i citati nella bibliografia dall’autore) e Lorenzo Natali, nel loro studio Cosmologie violente, propongono un percorso intenso nell’ambito della criminalità, con l’intento ancora una volta di addentrarsi nella questione, superando i luoghi comuni. Sono loro due a sottolineare come il meccanismo di protezione che scatta immediatamente di fronte a un gesto violento e tragico è quello della categorizzazione. Il gesto violento irrompe nella nostra quotidianità, mette a nudo la sua costituzione fragile, mostra «ciò che “dovrebbe” rimanere “sempre” nascosto». Crea il caos. Portando l’individuo a mettere in campo le certezze, le più semplici e immediate che ha a disposizione, per ripristinare l’armonia. Marcare una linea netta tra noi e il criminale, ancora una volta, è rassicurante.
Non so se Manuel Foffo e Marco Prato potessero rientrare in quelle che Hans Toch definisce warped personalities, ovvero individui «che agiscono violentemente a causa della loro natura eccessivamente egocentrica e/o manipolatoria, il che li rende incapaci di riconoscere i bisogni degli altri», o se si tratta più che altro di qualcosa che ha a che fare con la solitudine e con il bisogno di riconoscimento. Il romanzo di Nicola Lagioia è puntellato qua e là di richieste di aiuto più o meno esplicite da parte dei personaggi della vicenda. Come il biglietto che Marco Prato scrive ai genitori prima del tentativo di suicidio fallito in cui scrive «Ho scoperto cose orribili dentro di me e nel mondo» (Prato si toglierà la vita nel giugno del 2017, il giorno prima dell’inizio del processo). Oppure Manuel Foffo, che nelle prime pagine compare «stropicciato» nel suo dramma e che, durante gli interrogatori, prova a rivendicare la propria umanità.
Massimo Recalcati, pochi giorni dopo il delitto, scriveva su “La Repubblica”: «nei crimini di natura perversa come quello compiuto dai due giovani romani ai danni di un ragazzo di 23 anni, non si uccide per un obbiettivo perché l’obbiettivo è in sé stesso quello di uccidere. È un tratto del nostro tempo: il crimine appare sempre più erratico, vacuo e dissociato dal senso. Ogni trascendenza viene abolita e con essa ogni senso di compassione umana. Nella perversione il sentimento della pietas non può trovare alcun posto». Ancora una volta il vuoto, l’abisso, i nostri angoli bui, che non permettono di riconoscere «il sacro» che vi è “in ogni uomo”, per usare un’espressione cara a Simone Weil. Ed ecco che qui entra in gioco la giustizia e quello che è il suo compito: trovare il modo di riparare le ferite. Il castigo potrebbe allora divenire «l’arte di destare nei criminali il desiderio del bene» (sempre Weil). La risalita dall’abisso potrebbe avvenire percorrendo un cammino fatto di volti che si guardano e dialogano tra loro, provando a rappresentare il dolore e a dare spazio alla fragilità. O ancora, attraverso le due vie indicate da Lagioia: «rompere un silenzio terrificante» e «compiere il primo passo».

Riproduzione riservata